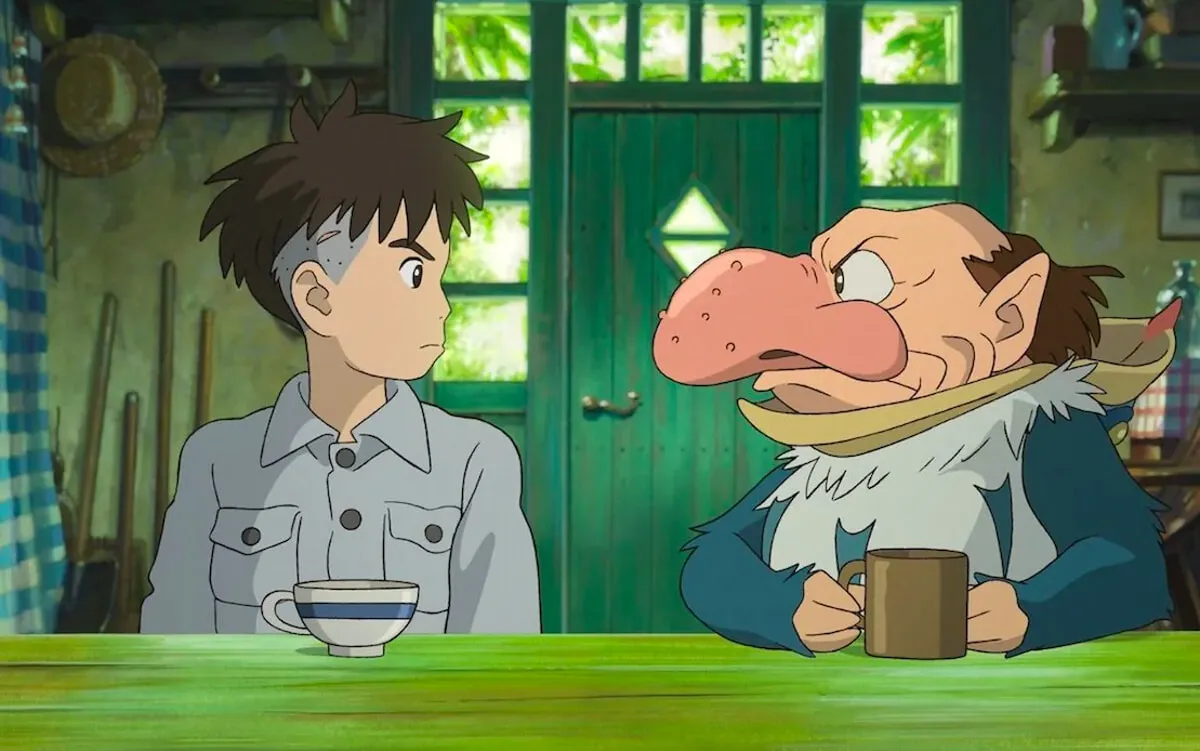LA CORNUCOPIA DEL CINEMA
Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

L’ANNO NUOVO CHE NON ARRIVA
Non ci sono più aggettivi per definire la cornucopia di autori provenienti dal cinema romeno. Curiosamente mancava il “grande film” su Timisoara. Ci prova l’esordiente Bogdan Mureșanu, e ci riesce, vincendo Orizzonti 2024. L’idea-chiave è raccontare la rivolta attraverso alcuni personaggi qualsiasi, con struttura a episodi vagamente intrecciati, che illumina le giornate di dicembre 1989 con gli strumenti della commedia nera. Più accessibile di Jude e forse anche di Mungiu, l’autore guarda a Monicelli, Scola e persino Lelouch (si veda l’uso del bolero finale), oscillando tra satira tagliente (basti pensare al tentato suicidio o alle letterina per Babbìo Natale) e sincera indignazione. Senza rinunciare a nessuna delle due.
PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK
Come fu per la Siria (conflitto dimenticato, e purtroppo cinema dimenticato) anche la tragedia di Gaza stimola forme stilistiche. Se La voce di Hind Rajab aveva spinto il doc nella finzione, rischiando, Sepideh Farsi lavora sugli schermi. Quello del tablet/smartphone è l’unico contatto possibile con una giornalista palestinese, l’unico possibile per vedere le sue foto e ascoltare la sua voce. Anche stavolta, la fine è purtroppo nota. Quella registrazione insiste a ricordarci che la morte dalle bombe arriva in mezzo secondo mentre le storie al cinema durano due ore con cui conosciamo vite intere, rimanendo sconcertati e annichiliti dal “the end”. Inquadrare uno schermo è questione di morale.
DIE MY LOVE
L’inizio è esaltante. Inquadratura fissa, una casa e i suoi fuori campo, una coppia e il suo futuro – sembra uno spin off di Here. E poi la musica urticante con cui i due segnano il territorio. E poi una pancia, e poi l’infanzia, anti-malickiana, perché in quella casa dentro la natura c’è soprattutto frustrazione. Dopo, però, Lynne Ramsay – pur mantenendo un interessante approccio al vetriolo, antifrastico e pieno di graffi – si adagia pian piano nell’ennesima lettura metaforica della depressione post parto e materna (da Baby Ruby a Nightbitch il cinema sembra solo sfiorarne il pozzo profondo), con un finale a dir poco irritante. Peccato per Jennifer Lawrence, scatenata (Robert Pattinson spaesatissimo, invece).

ZOOTROPOLIS 2
Byron Howard e Jared Bush tornano con un secondo episodio a distanza di anni – anche perché non era all’inizio evidentissimo quanto il capostipite avrebbe attecchito nell’affetto del pubblico. A Zootopia stavolta ci sono nuovi capri espiatori, anzi rettili espiatori, e la coppia Judy/Nick – sempre più buddy comedy – deve sbrigliare un nuovo complotto. Qua e là le esigenze di ricalcare il primo episodio (molto simile come struttura) frenano il potenziale, così come la quota action rischia di prevalere, ma il discorso anti-razzista e forse anti-trumpiano si staglia netto. Animazione di nitore impressionante, citazioni riuscite, e una qualche aria da Chinatown. Al proposito: non è Rango (strepitoso e poco ricordato) ma si gode comunque.
TRAIN DREAMS
Direttamente su Netflix arriva un “attenzionato” da Oscar: il western di Clint Bentley passato al Sundance. Un monumentale Joel Edgerton offre corporeità ed espressione all’uomo qualunque raccontato da Denis Johnson nel suo bellissimo romanzo, di cui Train Dreams è trasposizione temeraria. Proprio dal lato narrativo arrivano le cose migliori, per la voce fuori campo e la meditazione solitaria di un destino comune a tanti anti-eroi di frontiera d’inizio Novecento – in un’America sterminata, inospitale, durissima. Lo stile malickiano funziona meno, per un semplice fatto: non c’è Malick dietro la mdp. Nulla che 1883 di Taylor Sheridan non abbia raccontato alla grande, ma sicuramente dignitoso e profondo.
LA FEBBRE DELL’ORO
Sono passati cento anni ed è stupefacente osservare con questo restauro 4K la modernità irriducibile del Chaplin forse più sperimentale di sempre. Lo spiazzamento, ogni volta che si guarda The Gold Rush, è comprendere che si tratta principalmente di un dramma: è il Greed di Charlot. Ci sono avidità, violenza, pazzia. E c’è un survival dentro cui si sviluppa una passione romantica unilaterale e folle (si veda la sequenza in cui il vagabondo impazzisce di gioia perché pensa di aver ottenuto un appuntamento dall’amata: è il delirio). Poi – certo – ci sono le scene da antologia slapstick, la casa che penzola, la scarpa bollita, la danza delle forchette, e tutta la poesia chapliniana. Ma nulla pareggia la solitudine che esprime, dentro una struttura a tre atti decostruita dall’interno. Indimenticabile.

FINO ALLA FINE DEL MONDO
Nessuno ha mai visto davvero Fino alla fine del mondo (1991). La Director’s Cut restaurata in 4K, supervisionata dalla Wim Wenders Stiftung, che CG Entertainment porta nelle sale italiane, è la forma definitiva di quasi 5 ore. A distanza di oltre 30 anni, si capisce molto meglio la clamorosa lungimiranza di Wenders nel parlare di immagine elettronica. Non senza un certo afflato predicatorio (tipico del regista a cavallo tra Ottanta e Novanta, che oggi appare assolutamente perdonabile), il film assume in digitale (sbalorditivo, peraltro) una coerenza assoluta. Il rapporto tra road movie – paesaggio esterno – e registrazione dei sogni – paesaggio interiore – recupera un respiro perfetto, così come i personaggi (fin troppo ermetici nella versione di allora) ridiventano verticali. Una sfida alla pazienza? Sì, ma ripagata con gli interessi.
THE PITT
Che cosa chiediamo al medical drama? Domanda essenziale per capire che cosa fare di The Pitt. Da una parte non c’è nulla di nuovo: un pronto soccorso, ovviamente acqua alla gola, ovviamente sotto organico, ovviamente con mille problemi personali, ovviamente con casi bizzarri e pericolosi da affrontare. Dall’altra c’è un consapevole rapporto intertestuale con E.R. e su come rappresentare questi spazi da trincea del corpo ferito, c’è Noah Wyle che gioca con la sua storia, c’è una formula alla 24, quindi c’è un rapporto teorico con certa serialità Novanta/Duemila che diventa scuola estetica. E il mini-ciclo interno di episodi sulle vittime di un attacco terroristico è davvero mozzafiato.