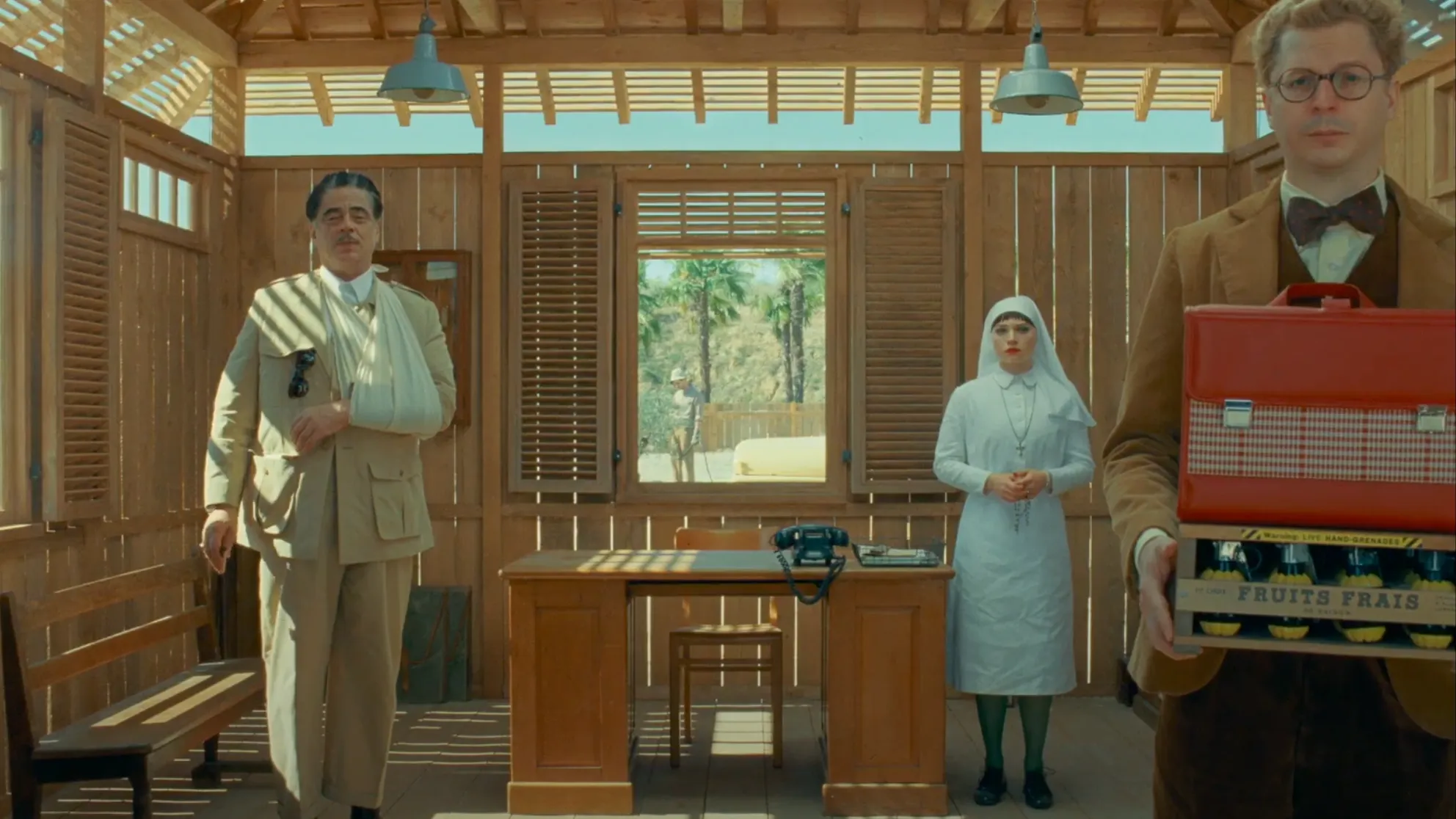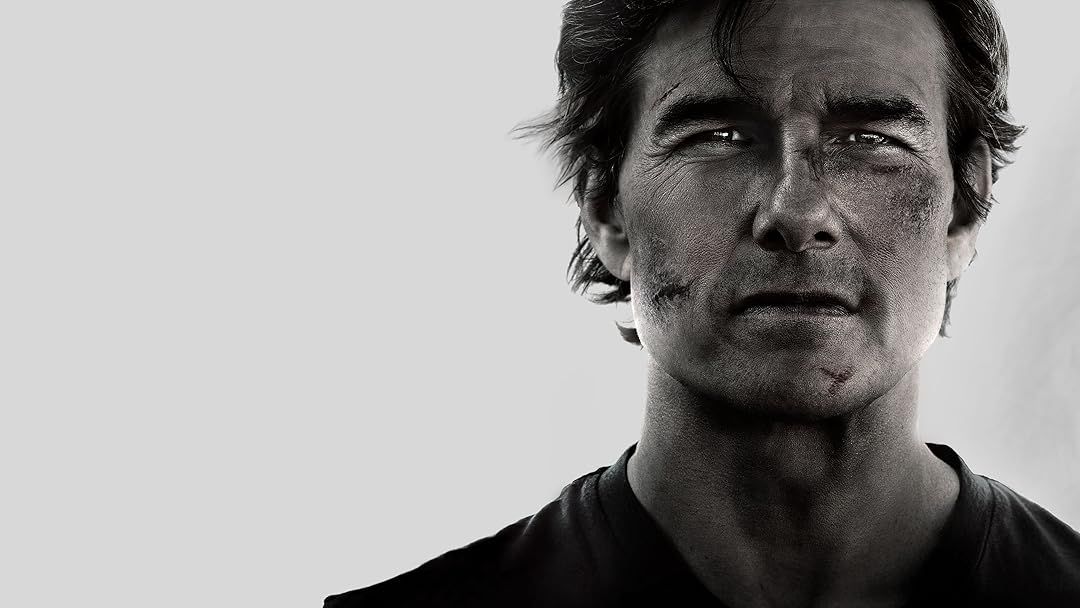IL SUONO DEI RITORNI
Come di consueto la rubrica “In poche righe” affronta alcuni film e serie TV attraverso rapidi lampi critico-interpretativi.

IL SUONO DI UNA CADUTA
La storia si muove attorno a una famiglia tedesca lungo alcune generazioni, segnate da un passato opaco in mezzo a traumi personali e comunitari. Il suono di una caduta è uno dei film dell’anno, oscuro, raro e potentissimo, che fa due cose sorprendenti: cercare una sorta di vibrazione stilistica capace di attraversare il tempo (e la rappresentazione), e dare alla Morte (non a caso Bergman si sente in molti passaggi) non più un corpo bensì uno sguardo. Il sospetto, infatti, è che sia la narratrice, o – come si diceva un tempo – l’istanza enunciativa. Mascha Schilinski costruisce un paesaggio emotivo fatto di silenzi, omissioni, dettagli con una lenta sedimentazione di memoria che riaffiora per frammenti. E giustamente se ne frega di chi le chiede moderazione formale o sintesi narrativa (secondo la critica del “togli un quarto d’ora” che va tanto di moda).
MIROIRS NO. 3
Il mistero di una sopravvissuta a un incidente e la strana famiglia che la ospita dopo il trauma. In Miroirs No. 3 Christian Petzold torna a lavorare per sottrazione, con quello sguardo di “minimalismo gravido” che sembra essere la sua cifra migliore (un po’ come se ogni inquadratura fosse il riflesso imperfetto di un’altra storia possibile). Il film è un gioco di superfici, di rimandi, di identità che si sdoppiano senza mai coincidere davvero – con l’ennesimo fantasma di Hitchcock che aleggia pur dentro un luogo di provincia e una casa di campagna quanto mai anonima. I personaggi sembrano attraversare lo schermo come presenze in cerca di una forma, più che di una soluzione narrativa.
TIENIMI PRESENTE
In Tienimi presente Alberto Palmiero racconta di una gioventù creativa, forse velleitaria, spinta ai margini della stabilità affettiva e lavorativa, priva di punti d’appoggio culturali. Oppure è solo la storia di un giovane informatico che al suo destino preferisce fare il regista precario, senza grande successo (trama prevalente alla lettera, ma curiosamente meno flagrante dell’altro). Palmiero, esordiente, sceglie un tono dimesso, quasi laterale, e lascia che siano i gesti a costruire il senso delle relazioni, con la ritrosia di Massimo Troisi e attraverso il (curioso) modello del cinema italiano degli anni Ottanta – più morettismo che Moretti. Ne esce un racconto generazionale che evita diagnosi sociologiche e preferisce restare aderente ai corpi, ai tempi morti e alle attese, con dolcezza e una certa, benvenuta vulnerabilità.

SCREAM 7
Avete detto fan service? D’altra parte, per un progetto che nasce come autofagocitazione dell’horror (e progetto pienamente postmoderno, fin dal “Munch pop”), non è che si debbano attendere svolte mistiche. Il precedente episodio segnava una certa malinconia quasi “postuma”. Qui, nelle mani di un Kevin Williamson ormai forse in ritardo sul tempo presente, si sviluppa una celebrazione accumulatoria del primo episodio trent’anni dopo – sia pure con una dimensione di deliberato suicidio carnevalesco. Ci si diverte sempre, specialmente con i capitomboli e le efferatezze quando in scena c’è GhiostFace. Meglio tacere, invece, di quel che si scopre quando si alza la maschera.
LE GRAND CIEL
In Le Grand Ciel Vincent lavora di notte nel cantiere di un nuovo quartiere avveniristico che promette progresso e rilancio. Quando un operaio scompare, i capi archiviano in fretta e il sospetto di un insabbiamento prende corpo; poi le sparizioni aumentano e il cantiere diventa un labirinto. Akihiro Hata usa la fantascienza allegorica come lente sul lavoro precario e sulla paura di scivolare in basso. Ottimo il lavoro su immagini e suono: il cemento diventa materia che inghiotte, il rumore industriale un ritmo che porta alla sparizione umana. A metà tra Cantet e Siegel, un film inquieto, sociale senza proclami, solo qua e là un po’ didascalico.
GOMORRA – LE ORIGINI
Ammettiamo qualche pregiudizio al momento di cominciare la serie. Pronti come sempre a ricrederci. E infatti il prequel di Gomorra ha trovato una chiave, tra vintage e violenza (pensiamo a un ircocervo: Rovere/Sybilia che incontrano un Sollima dal cuore bellocchiano). La Secondigliano del ’77 come laboratorio sociale e criminale lavora sul “prima” senza rassicurare: non giustifica, ricostruisce i passaggi, mostra come un quartiere violento possa diventare un metodo criminale, quasi una mistica sociale. E così il prequel, invece di ammorbidire il mito, lo rende più inquietante. Aprendo potenzialità importanti per le prossime stagioni.
THE NIGHT MANAGER 2
Strana scelta, quella di ripescare una serie di dieci anni fa (sia pure riuscita) e darle un seguito. Anche stavolta, però, tanto di cappello. La serie cambia scenario e temperatura: hotel e lusso restano sullo sfondo, rispetto a prima, mentre la vicenda si concentra sul lavoro di intelligence e sulla geometria delle coperture. Hiddleston torna più controllato e più stanco, Colman mostra la fragilità di chi è minacciato, Laurie fa davvero paura. E il pretesto del sequel diventa un modo per aggiornare Le Carré all’oggi: armi, potere, affari, fedeltà a geometria variabile, guerra come unica modalità relazionale. E un finale così tosto era difficile aspettarselo.