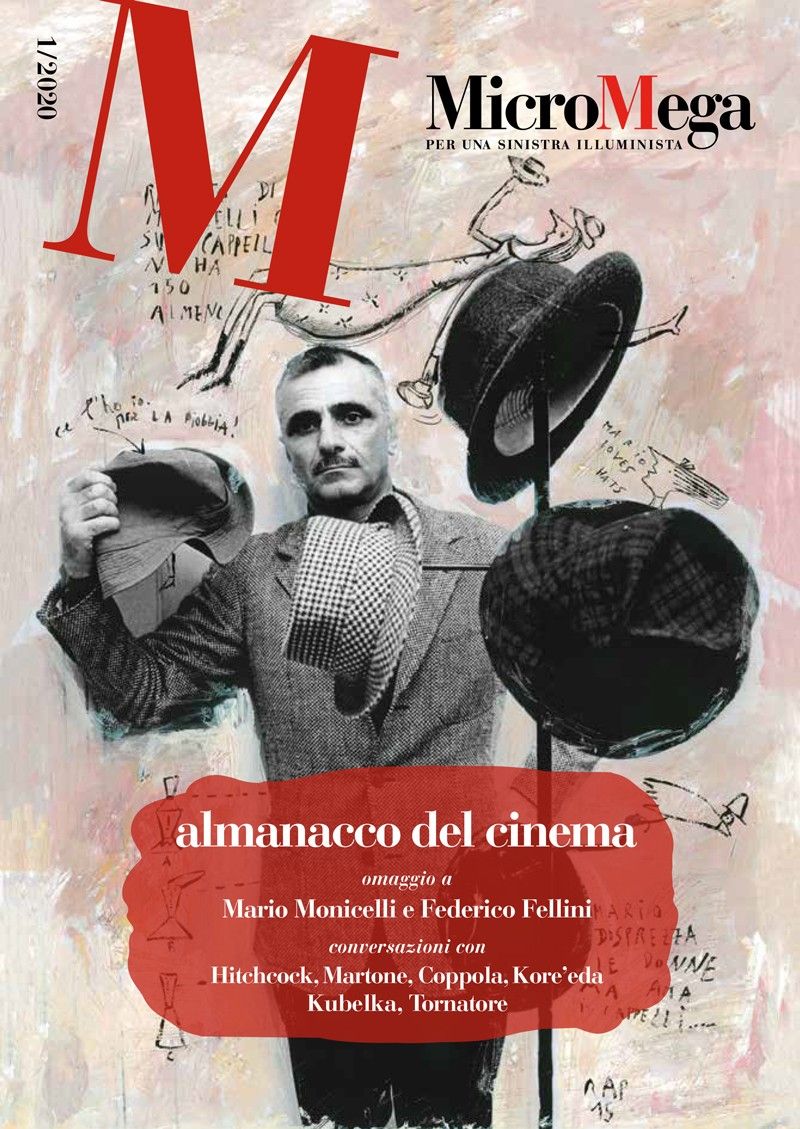Cominciamo dal titolo di questo saggio (che riprendo da una vecchia pubblicazione oggi praticamente scomparsa, La superficie e l’abisso. Percorsi culturali politici nel cinema americano degli anni Ottanta, a cura di Enrico Cassini, 2010). Tornare alle cose concrete. Dure. Non riducibili. Indigeste,
Gli anni Ottanta sembrano davvero per la maggior parte come ce li ricordiamo: euforici. Certo, in ogni decennio coesistono tante diverse ipotesi di cinema, come dimostra in questo periodo la convivenza di Top Gun e di Videodrome, solo per fare un esempio. Eppure, il fantastico sembra davvero declinato in maniera infantile e rassicurante: robottini (Corto Circuito e seguiti), forme aliene paradisiache (Cocoon e seguiti), avventure preadolescenziali (Goonies), mostriciattoli colti e cattivelli ma tutto sommato dall’aspetto di giocattolo (Gremlins e seguiti), alieni buoni o buonissimi (dal capostipite E.T. ai vari Explorers e compagnia).
Naturalmente gli anni Ottanta sono anche la decade di Cronenberg e Lynch, di McNaughton e Mann, di Friedkin e di Romero. Tuttavia, bisogna forse concentrarsi più attentamente sul cinema mainstream e su una sfida particolare, quella portata da John Carpenter e dal suo La cosa, per comprendere meglio che cosa significa lavorare davvero “contro” il periodo di appartenenza.
Come si sa, il film di Carpenter, oggi quasi assurto al rango di culto, è stato all’epoca un grave insuccesso. Il film, costato circa 30 milioni di dollari, ne aveva guadagnati in America solo 13, e nel resto del mondo assai meno. Si è dunque trattato di un passo falso commerciale da parte di un autore assai stimato dal grande pubblico, che pareva non perdonargli un film così adulto, fosco e drammatico. The Thing in effetti usciva “rated R”, dopo la catastrofica minaccia iniziale di un “rated X” (quello dei porno), che gli avrebbe bloccato qualsiasi uscita. Ma già la “R”, e le voci di rimaneggiamenti e tagli sono stati sufficienti ad allontanare la massa e scontentare i fan duri e puri. Oggi il film è visibile integrale in DVD, ma all’epoca – anche in Italia – la copia che girava era assai tagliata.
Parliamo del 1982. Anno importante per tutto il cinema americano, sottoposto contemporaneamente a un terremoto fantascientifico senza precedenti (il già citato E.T. di Spielberg) e a un sovvertimento dell’immaginario apprezzato nella sua entità solo parecchio tempo dopo (Blade Runner). Basta la spiegazione del “troppo dark” per poter interpretare l’insuccesso del film di Carpenter? O non sarà forse che il pubblico non aveva alcun desiderio di confrontarsi con fobie così allarmanti e rappresentazioni tanto sanguinose del proprio presente? Come ogni grande film, infatti, anche La cosa – pur così “hawksiano”, diretto, concreto, ruvido, di genere – contiene ampie metafore. La microsocietà di cowboy del ghiaccio, annoiati e stanchi, immersi in un inverno senza fine, appare come l’esatto contrario di una società statunitense sempre più opulenta, affacciata al sogno reaganiano della deterrenza militare e della ricchezza borghese. Vedere questi stessi uomini, le “avanguardie” mandate in capo al mondo, esportare una democrazia fragile e autodistruttiva, divorati dal sospetto l’uno per l’altro e da un elemento esterno che si finge umano, fa risuonare molti echi. Va da sé, infatti, che la critica politica non tardi a sposare il film: “L’insostenibile, indigesto e demodé La cosa, remake hard e magnifico dell’Hawks/Nyby del ’51, firmato da John Carpenter in Alaska durante l’anno 1981, quasi all’inizio dell’era Reagan. Immagine e sostanza di quella ‘ferocia senza salvezza’ che è la sintesi del fantastico per Carpenter, di quell’America che credi amica e onesta e invece ti assalta al collo quando meno te lo aspetti”. Parole di Roberto Silvestri, sul Manifesto.[1]
Proporre in termini antinomici il confronto La cosa/E.T. è certamente scolastico. Molti hanno notato come anche il film di Spielberg, in effetti, contenga accenti piuttosto critici nei confronti delle istituzioni e dei governanti, mal disposti ad accettare il diverso e a farlo convivere con noi. D’altra parte, è altrettanto vero che il cinema di Spielberg in questi anni tende a omogeneizzare il pubblico in nome dei valori comuni dell’America di provincia e dei fondamenti costituzionali cari ai registi umanisti e democratici. Il modello di E.T. è Frank Capra (che amava assai poco i governanti: dice nulla Mr. Smith va a Washington?), senza per questo vestire i panni del rivoluzionario. Il nume di Carpenter è invece – come più volte ammesso dallo stesso cineasta – Howard Hawks, in virtù del magistero di secchezza narrativa e ricchezza metaforica che ne deriva. Attraverso la sottrazione e il “levare”, si giunge al nocciolo. Azione pura, dunque, per questo film che non ha davvero un momento di tregua, che impressiona per densità e ritmo anche visto tanti anni più tardi.
Non è un caso che la critica americana, assai contraria alla violenza del film, abbia stigmatizzato la furia “hardcore” del lavoro di Carpenter. Non si tratta di pornografia nei termini tradizionali del concetto, evidentemente, piuttosto di una esposizione totale dell’orrore, di una disposizione a “vedere tutto” e a non occultare nulla, proprio come fa la “Cosa” quando fuoriesce dai corpi che la ospitano. Si tratta di una “pan-visibilità” diversa da quella di Cronenberg, perché accolta nell’alveo di un genere né denegato né intellettualizzato, laddove il cineasta canadese lavora sull’eccesso attraverso la speculazione filosofica. Questa profondità della visione, nella sua esplosione improvvisa a partire dal già noto o dall’apparentemente conosciuto, contiene più di un motivo interpretativo.
Di quello politico, abbiamo detto: l’America non è così pacifica come sembra, e le microsocietà che la rappresentano ne sono dimostrazione non appena vengono messe in discussione. Dal punto di vista meta-cinematografico, c’è altrettanta carne al fuoco (è il caso di dirlo, per un film in cui lattice e lanciafiamme prendono il sopravvento). La nota lettura di Enrico Ghezzi, per esempio, offre questa prospettiva: “La cosa è il principio stesso della trasformazione, adottato per la prima volta insieme come forma narrativa, oggetto della narrazione, generatore di immagini. Che la cosa sia il cinema ribaltato all’interno di se stesso è abbastanza chiaro. (…) Da sempre citazionale e referenziale, il cinema di Carpenter affrontando direttamente il ‘cinema’ con la forma-remake si concentra e si compatta di colpo in una macchina infernale che deve mordersi la coda senza alcun dolore o contraddizione, perché la macchina/cosa è questo mordersi la coda”. [2]
Sia che immaginiamo – con Ghezzi – che “the thing” sia il cinema, ovvero che il film di Carpenter parli di un oggetto metamorfico e irriducibile, ribelle e aggressivo, imprendibile (teoricamente) e affascinante (poiché ci guarda e ci pietrifica in stile Medusa, come dimostra il primo cadavere congelato a guisa di body art); sia che invece di meta-cinematografico nella Cosa troviamo soprattutto la sfida lanciata alla rappresentazione ottantesca del film americano; in entrambi i casi, diciamo dunque, la lettura non appare priva di fondamento. E anche quando si sfiora l’interpretazione in eccesso, essa viene tranquillamente riassorbita nell’ordine del credibile, almeno alla luce di quanto avvenuto nel cinema americano di quel decennio.
Secondo Luc Lagier e Jean-Baptiste Thoret, per esempio, l’orrore della “Cosa” “risiede anzitutto nell’incapacità dello spettatore a determinare la forma originale e invariante del nemico. Le sue aberrazioni organiche e morfologiche sfuggono infatti a ogni tentativo di classificazione. (…) La Cosa possiede tutte le caratteristiche di una creatura abietta”.[3]
Molto si deve all’unità di luogo e azione. L’Antartide offre uno spazio immenso ma evidentemente impraticabile. Il freddo assedia i protagonisti, per cui “là fuori” non c’è salvezza. Il che è molto suggestivo, visto che Carpenter non cerca neanche un momento di nascondere i propri riferimenti al western, a cominciare dall’abbigliamento dei personaggi, agghindati con orpelli da cowboy. MacReady – alias Kurt Russell –, poi, è un classico eroe westerner: di poche parole, rude, un po’ paranoico, insofferente alle regole, certamente impaurito ma con le caratteristiche immanenti del leader. Veste pantaloni sdruciti, giacche di cuoio, cappelli da cowboy e tiene la pistola nella fondina legata alla gamba. Ora, se ci limitassimo a queste allusioni di maniera, ci sarebbe poco da riflettere. Invece, il gioco di Carpenter è più sottile: il rifugio del gruppo è un fortino, un altro avamposto è stato assalito e la visita di MacReady e del dottore rimanda a quella di mille film western nei quali si giunge a carneficina avvenuta (ricordate la distesa dei corpi martoriati da Sierra Charriba quando arriva Charlton Heston, nell’omonimo film di Peckinpah?). Ma, sublime crudeltà, nessuno può prendere un cavallo e mettersi in fuga nelle distese rocciose o a spasso nella prateria. Il bivacco finale, anch’esso western, dei due sopravvissuti, è destinato a vita breve. Un po’ di whisky e qualche fiammella potranno proteggere ben poco i personaggi assediati dal gelo e dalla “Cosa”. Fuori non c’è salvezza (lo spazio aperto è dunque un luogo di morte certa) e dentro c’è il nemico. Una situazione senza uscita, dunque, oltre che un asse narrativo sul quale costruire gli elementi di tensione e sofferenza.
La cinefilia come remake permane – nel film di Carpenter – a temperature piuttosto basse, laddove invece la passione per il gioco, per la strizzata d’occhio, per il ludico disincanto permea le altre pellicole del decennio, al di là del valore che si vuole attribuire ad esse. Carpenter è seriamente deciso a escludere ogni tipo di pastiche, a trasformare l’originale in qualcosa di differente, capace cioè di “trattenere” elementi di inquietudine già presenti, in ciò offrendo davvero una nuova lettura interpretativa dell’archetipo. È ben facile, infatti, affermare che ogni remake fa luce su aspetti meno studiati del proprio modello testuale, ma quasi mai è vero. Con The Thing, invece, certamente siamo portati a guardare con occhi nuovi anche al film di Hawks/Nyby, riconoscendovi da una parte la mano del cineasta (non accreditato, come noto), e dall’altra i temi identitari e fantahorror che rimanevano un po’ celati (o gelati) a causa del ritmo non proprio travolgente della pellicola. Carpenter non gira perciò The Thing Reloaded bensì un film che cerca di estrarre, come oro dalla sabbia, la dimensione più pulsionale e diretta del capostipite. “Per Hawks ‘la cosa’ cementava la coesione del gruppo, per Carpenter contribuisce definitivamente al suo disfacimento e i suoi invasori danno la misura di ciò che noi realmente siamo e non di quello che vorremmo essere, ribaltando non solo la visione di Hawks, ma di tutto il filone della cosiddetta ‘invasione aliena’ in voga negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta”.[4]
Secondo alcuni critici si tratta comunque di un’opera postmoderna: Philip Brophy afferma che “La Cosaè un film violentemente autoconsapevole” e Isabel Cristina Pinedo sostiene che il crollo di tutte le difese, rifugi, confini alla fine del film sia una metafora della postmodernità.[5] Forse è vero, a livello di materiali narrativi. Il nocciolo, però, è neoclassico, come sa essere Carpenter, solo forse insieme a Clint Eastwood. La cosa da un altro mondo, nella produzione americana degli anni Ottanta, non è il cinema in sé: è il cinema di John Carpenter.
[1] Roberto Silvestri, “Carpenter 1983-1986. Vomitando sull’orrido decennio”, in Giulia D’Agnolo Vallan, Roberto Turigliatto, a cura di, John Carpenter, Torino Film Festival, Lindau, 1999, p. 213.
[2] Enrico Ghezzi, “L’entità della cosa (il doppio del cinema)”, Paura e desiderio. Cose (mai) viste, Bompiani, Milano, 1995, p. 225.
[3] Luc Lagier, Jean-Baptiste Thoret, Mythes et masques: les fantômes de John Carpenter, Dreamland, Paris, 2006, p. 24 (traduzione mia).
[4] Fabrizio Liberti, John Carpenter, Il Castoro, Milano, 2003 (2° ed.), p. 60.
[5] Philip Brophy, “Horrorality – The Textuality of Contemporary Horror Films”, in Ken Gelder, a cura di, The Horror Reader, Routledge, London and New York, 2000, p. 282 (traduzione mia); Isabel Cristina Pinedo, “Postmodern Elements of the Contemporary Horror Film”, in Stephen Prince, a cura di, The Horror Film, Rutgers University Press, New Brunswuick, New Jersey and London, 1999, pp. 102-106 (traduzione mia).