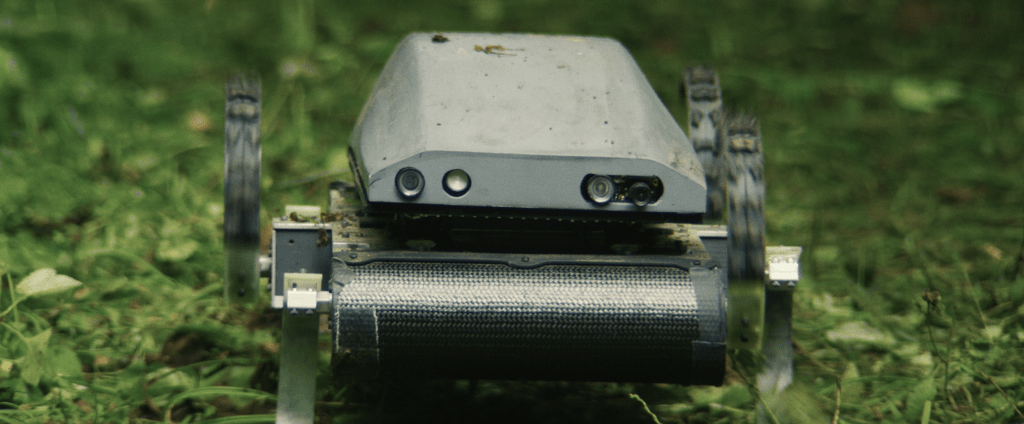Autore: Roy Menarini
ripensare “io, io, io…e gli altri” di alessandro blasetti
Quasi tutti gli storici riconoscono in questo decennio la centralità di un film come Io, io, io…e gli altri (1966), quasi un sole intorno al quale gravitano tutti gli altri piccoli satelliti, che si chiamino essi Liolà, La ragazza del bersagliere, o Simon Bolìvar (vanno esclusi Io amo, tu ami…, e “La lepre e la tartaruga”, episodio di Le quattro verità, analizzati altrove coerentemente con il progetto cinematografico, documentario o film a episodi, di cui fanno parte), tutte pellicole che ci sembra abbiano subito un trattamento in ogni caso troppo sbrigativo nel corso degli anni e che potrebbero per lo meno essere riprese in considerazione a seconda del rapporto che esse intrattengono con il cinema coevo, con i miti del film d’autore o con le contraddittorie evoluzioni della commedia all’italiana. In queste righe cercheremo dunque di procedere con una lettura, sia pure superficiale, delle molteplici influenze presenti nel cinema di Blasetti anni ’60, non dimenticando del resto l’operatività di una poetica drammaturgica e ideologica mai dispersa.
Non di meno, bisogna fare anche esercizio d’umiltà e acquisire l’autocandidatura di Io, io, io…e gli altri a film testamentario, a memoriale d’autore, a ultimo grande diario di una personalità poliedrica del nostro cinema. Accettiamolo, dunque, come centro gravitazionale, ma non dimentichiamo gli errori fatti già nella prima parte della sua carriera quando molti osservatori non comprendevano la febbrile “incoerenza” di un regista che passava dal cinema storico alla leggenda fantastica fino a giungere alla commedia paesana proto-neorealista. Sull’importanza di Io, io, io… per Blasetti non esistono dubbi, basta leggere alcune dichiarazioni del regista[i] quando afferma: “Questo sarà un film tutto composto di episodi anche brevissimi, l’uno di diverso ambiente dagli altri, purché tutti suggeriti e provocati da un tema unico; un film di annotazioni, osservazioni, riflessioni che si possano tradurre in episodi anche minuscoli”. E a certificazione dell’investimento affettivo alla base dell’opera: “Questo sarà l’ultimo film con il quale farò trepidare produzione e noleggio per la mania di cercare nuove strade o meglio nuovi sentieri alle possibilità espressive del cinema. Sarà l’ultima volta perché bisogna che io dia un’occhiata all’anagrafe, finisca con l’accorgermi degli anni che ho e del mio dovere, direi, di mettermi da parte”.
Già sperimentata la formula del film a episodi (Altri tempi, Tempi nostri in largo anticipo sul momento in cui tale struttura diventa un’abitudine della nostra industria cinematografica), superato il documentario-varietà comunque spezzettato in diversi “numeri” (Europa di notte e Io amo tu ami), sembra quasi che con Io, io, io…e gli altri Blasetti abbia voluto radicalizzare l’esperienza e costruire un film dove fosse davvero difficile individuare uno scheletro di fondo. Intuendo probabilmente la sclerotizzazione cui il cinema ad episodi andava incontro, Blasetti ha optato per un film-diario, un cinema-appunti (ma sia chiaro: di attentissima e sorvegliata composizione poetica) equidistante sia dalle rivoluzioni del linguaggio classico provenienti dalle nuove onde europee sia dalle forme di microcommedia che la seconda parte degli anni ’60 riservava numerose. Ispirato, ma solo vagamente, all’intenzione di denunciare l’egoismo umano, compreso autobiograficamente l’egoismo dell’autore, il film di Blasetti presenta una prima cornice narrativa ambientata in treno (Milano-Roma): il protagonista Sandro, giovane scrittore interpretato splendidamente da Walter Chiari, conversa con il capotreno (Nino Manfredi), un tipo ossessionato dal sesso, dopo aver fantasticato su un’inchiesta riguardante appunto il “vizio dell’io”. Da questo spunto nascono i pensieri di Sandro: si tratta il più delle volte di ricordi, ma anche di fantasticherie, di memorie che prendono una forma fittizia, e di riflessioni. Dopo alcuni avvenimenti (la morte dell’amico Peppino), Sandro è costretto a ritornare a Milano in aereo, e in seguito di nuovo a Roma in treno, dove ritrova il compagno di viaggio Manfredi ma soprattutto rivede (senza essere scorto) Silvia, grande amore abbandonato per fatuità ed egoismo.
Già Aldo Bernardini, in una recensione del 1966, ricordava la struttura felliniana del film. Audace, acefalo, il racconto blasettiano segue infatti il tenue filo dei pensieri anche se sembra in qualche modo rifiutare quell’idea di “orchestrazione” narrativa di La dolce vita, quasi essendone una versione più moralista e al contempo meno ossessionata dal capolavoro “da farsi”. È evidente la prossimità tra i due autori in certi passaggi: la diva interpretata da Silvana Mangano si chiama Silvia e riassume in sé tanto la società dello spettacolo romano quanto l’innocenza di un’occasione mancata e irrecuperabile; lo stesso Chiari (ingiustamente accusato di recitazione discontinua: ma forse oggi siamo più abituati al sottotesto malinconico della sua maschera comica, ciò che allora doveva apparire stridente), somiglia per certi versi a Guido o Marcello. Il gioco prende la forma della citazione quando il Peppino interpretato da Marcello Mastroianni finisce al cinema dove proiettano 8 ½. Il continuo ritorno di Silvia, e la sua immagine enigmatica (su uno sfondo di foto da copertina che la ritraggono come “congelata” da quello stesso attimo di realtà) denunciano semmai suggestioni antonioniane, anche se poi la presenza ossessiva dei paparazzi, le sequenze veneziane, il primo incontro al concorso di bellezza riportano nuovamente a Fellini; e non dimentichiamo che, comunque la si voglia vedere, il film è prodotto dalla Cineriz, il che corrobora l’ipotesi di una derivazione troppo diretta per essere solo un omaggio.
È qui, però, che va concentrata la nostra attenzione: non un plagio suggerito dalle nuove possibilità del cinema d’autore, bensì un coraggioso ibrido sceneggiato dai grandi della commedia all’italiana (compaiono infatti: Suso Cecchi d’Amico, Benvenuti/De Bernardi, Age/Scarpelli, etc.), interpretato da un attore comico in collaborazione con alcuni mostri di recitazione, tra cui certo Mastroianni, ma anche De Sica, e una folta schiera di “guest stars” tra cui la Lollo, Valeri/Caprioli, la Koscina, Pisu e Panelli, Urzì e Croccolo, Luttazzi e Randone, cast eterogeneo anche per un decennio abituato a mescolare. Forse il film di Blasetti rappresenta un esempio militante dell’inestricabilità di rapporti che intercorrono nel decennio sessantesco tra film d’autore e commedia, coinvolgendo persino la comicità di serie b (filone scapolistico e ombrellonistico, varietà televisivo, sottogenere stile-Franca Valeri, satira radiofonica) in un caleidoscopio infine riuscitissimo.
Si diceva della complessità narrativa del film. Pensato come un flusso di memorie, Io, io, io…e gli altri mantiene più che altro alcuni personaggi “ossessivi”, che percorrono la storia dall’inizio alla fine e fungono anche da cesure del racconto: il Precossi interpretato da De Sica (somigliante chissà perché a Mario Carotenuto) riassume tutti i vizi, più che dell’egoismo, dell’opportunismo sociale, della spregiudicatezza dopo-boom: accompagna i ciechi sulle strisce per poter attraversare più celermente, bacia la statua del santo solo dopo averla disinfettata, finge e mente di continuo; le scenette più repentine di Percossi appartengono alla tradizione dei Mostri (fors’anche esplicitamente citato) piuttosto che alla vera natura del film; negli altri casi, il racconto si distende attraverso veri e propri macroepisodi, come quello che chiude l’opera, tutto dedicato al rapporto tra Sandro e Silvia. Vi è qui la rinuncia completa alla sferzata e al graffio satirico, che sono poi le cose a maggior rischio di invecchiamento, e si fa strada l’attenzione delusa a un rapporto cominciato come tanti altri, divenuto molto importante e finito malissimo: un ritratto di donna non inferiore a quelli che autori come Pietrangeli stavano componendo negli stessi anni. Se Silvia riassume in sé il ruolo dell’amante ma anche della donna “da amare” (in questo senso divergendo da Fellini dove lo spettacolo e le sue dive sono il luogo della tentazione), la moglie (una sensualissima Lollo, cui Blasetti dedica alcuni piani davvero intensi) è paradossalmente il luogo del trionfo sensuale, il ricatto della carne, non certo la noia domestica. Il primo piano che chiude il film, su Chiari mesto e insoddisfatto, è il più amaro dei finali blasettiani almeno dai tempi di Quattro passi tra le nuvole.
Ci sono anche momenti un po’ paternalistici, come il ciclico ripresentarsi dell’immagine dei due malfermi vecchietti nel parco, o la laboriosa derisione dei dittatori, doppiati nelle loro occasioni pubbliche dalla tiritera del “gioco della cucuzza” e concluso da un fungo atomico di dubbio gusto.
Se, come alcuni accreditano, Io,io,io…e gli altri è una specie di personale redde rationem di Blasetti nei confronti del proprio travagliato passato, non è certo a questa rappresentazione diretta di Mussolini che dobbiamo far riferimento, quanto piuttosto al commento sulla società e al distacco da ogni autoindulgenza: l’egoismo è qui davvero un brutto vizio, in ciò Balsetti non cadendo mai nei pericoli della commedia sordiana o nella commedia assolutoria della seconda metà dei Sessanta. Riuscito, invece, perché macabro e spietato, il corpo centrale del film: la morte di Peppino, la vanità del “coccodrillo” giornalistico, la cerimonia funebre, l’incapacità di piangere da parte di Sandro che deve ricorrere alla fantasia di sé stesso nella bara per poter versare qualche lacrimuccia; e di seguito l’insorgenza scandalosa del desiderio sessuale, laddove la morte dovrebbe oscurare tutto il resto.
Le perplessità su Chiari appaiono, come sostenuto poco sopra, francamente eccessive. È possibile che l’abitudine a vedere l’attore veronese in un momento della carriera discendente e in commedie ad episodi abbia fatto la sua parte: nel 1965 Chiari era comparso infatti in Made in Italy (episodio “Ogni bel gioco” di Nanni Loy), in Thrilling (episodio “Sadik” di Polidoro) e nell’antologico Risate all’italiana. D’altra parte, sia La rimpatriata di Damiani (1963) che il Falstaff di Welles (1966, dove ricopriva il ruolo di Silence) dovevano già contribuire a rielaborarne problematicamente la figura dinoccolata e doppiesca degli anni ’50, dominati per lui da registi come Mattoli, Bianchi e Soldati. A noi oggi sembra che l’attore sia in perfetta sintonia col progetto blasettiano, figura a suo modo opaca di aspirazioni frustrate e soddisfazioni ottenute a costo di gravi sensi di colpa. In definitiva, che cosa è Io, io, io…e gli altri se non una nuova forma di commedia, una commedia sperimentale, che scorre a lato di produzioni ufficiali assai più facilmente catalogabili nei generi vigenti?
[i] Ora in Blasetti, A, Il cinema che ho vissuto ( a cura di Franco Prono), Dedalo, Bari 1982, p.242.
di cinema e di mercato
Spesso escono in libreria studi che dialogano tra di loro, a volte per osmosi di settori disciplinari e di autori (come nel caso che stiamo per illustrare), a volte per semplice coincidenza editoriale. In questo caso riconosciamo una familiarità evidente, e non solo per la compresenza di alcuni nomi, tra i libri Pubblicità e cinema (a cura di Martina Federico e Ruggero Ragonese, Carocci, 21 euro) e Fellini e la pubblicità (a cura di Vanni Codeluppi, Francoangeli, 15 euro).
Cominciamo da quest’ultimo. Si tratta di un interessante proposta di miscellanea di saggi tutti già editi, alcuni dei quali redatti da figure che troviamo anche nell’altro volume (come Ragonese). Nell’agile pubblicazione troviamo anche un brillante contributo di Paolo Fabbri, purtroppo recentemente scomparso, e già autore di studi importanti sul Fellini pubblicitario. Ovviamente non si parla solo degli spot girati dal maestro riminese ma anche del rapporto con la pubblicità dentro i suoi film (“Bevete più latte” ecc.). In generale il volume sfata il mito di un Fellini che odia la televisione (non si interrompe un’emozione) e spiega come Fellini fosse contro gli usi distorti che le televisioni facevano del linguaggio pubblicitario, e che “voleva che questo fosse pienamente rispettato, perché pensava che avesse delle grandi possibilità creative e ci ha lasciato perciò degli esempi di pubblicità che devono essere considerati attentamente anche da parte dei professionisti odierni della comunicazione”.
In Pubblicità e cinema invece i curatori invitano fin da subito a porre attenzione all’ordine dei due termini. Sostanzialmente è un libro di saggi sulla comunicazione e la pubblicità applicato ai rapporti con il grande schermo, sia che si tratti di product placement sia che si tratti di pubblicità incorporate nei film (e narrativizzate), o ancora che si tratti di prodotti mediali apparentati in qualche modo con la dimensione promozionale. In quest’ultimo caso, alcuni di essi possono avere una loro autonomia linguistica ed estetica, come i fashion film, bene indagati in ben due contributi (di Buffo e Spaziante). Gli studi di Martina Federico sui trailer sono il cavallo di battaglia della ricercatrice da tempo, e ottengono qui ulteriore sistemazione, così come il già citato Ragonese offre a più riprese solidi tentativi di sistematizzare semioticamente il rapporto pubblicità/cinema. Forse manca un capitolo a parte dedicato al rapporto tra pubblicità e spazi perimetrali alla sala e al film (dal food merchandising alla cartellonistica, dalle pubblicità in loop negli atri agli spot locali pre-proiezione), ma il testo è assai denso, completo e segna uno spartiacque su un argomento curiosamente ancora inedito.
CAPIRE LE SERIE TV IN EPOCA POSTMEDIALE
Nel titolo abbiamo artatamente fuso due volumi usciti negli scorsi mesi, entrambi molto interessanti. Si tratta di Capire le serie TV (di Nicola Dusi e Giorgio Grignaffini, uscito per Carocci, euro 21) e di Mondi in serie (di Angela Maiello, uscito per Lucio Pellegrini Editore, euro 16). Sono accomunati dal tentativo di guardare alle serie TV evitando alcune risacche della critica e della teoria contemporanea: la dimensione esclusivamente narratologica, il confronto pigro con il cinema, l’esaltazione delle forme seriali in quanto tali, lo scarso interesse verso i contesti mediali se non nella fruizione, e altri ostacoli abbastanza visibili.
Dusi e Grignaffini lavorano su vari frangenti più recenti e dinamici, tra cui i production studies, le pratiche di scrittura e costruzione, gli adattamenti e le modalità transmediali. Non fanno l’errore di riferirsi a un numero troppo ampio di prodotti, anzi ne utilizzano alcuni di prima mano (come la serie italiana Made in Italy), non per forza artisticamente rilevanti, per svolgere uno studio sui materiali, sulla sceneggiatura, sul montaggio e sui rimaneggiamenti progressivi che il testo affronta – e perché – prima di arrivare allo spettatore vorace delle piattaforme. Ma anche Fargo e Breaking Bad entrano più volte sotto il microscopio degli autori, di volta in volta per indagarne gli effetti cinematici, lo stile o l’intertestualità, particolarmente reticolare e intensificata.
A sua volta, Angela Maiello scarta i luoghi comuni sulle serie TV e si pone la domanda fondamentale: che ruolo hanno nella nostra epoca? La risposta è che sono una forma di adattamento a un ambiente ibrido e molecolare come quello che i media, in epoca “post”, ci propongono ogni giorno. Come fanno a costituirsi come esperienza solida e integrata? Attraverso degli specifici seriali, di cui si comincia a scartare la dimensione “TV” (ormai superata in nome di un’offerta streaming consumabile su diversi dispositivi), e a privilegiare piuttosto altre ragioni: lo spazio, il tempo, la relazione con i media digitali, il rapporto tra mondo rappresentato e mondo dell’autorappresentazione nei social network e così via.
Ciò che intriga nel brillante lavoro di Maiello è l’ostinazione nel collocare la serialità contemporanea nel contesto delle nostre aspettative mediali e narrative, oltre che la capacità di far dialogare due tradizioni solitamente ben separate in bibliografia, ovvero un certo approccio teorico europeo (Bacthin e Ricoeur in particolare) con la ricca letteratura anglofona media studies di questi anni (Bolter/Grusin, Jenkins, Mittell ecc.), filtrata dalla scuola Casetti/Eugeni e dagli studi postmediali più recenti.
Due ottimi volumi con cui ricominciare a parlare di serialità, di cui andrebbe salutata forse una nuova era di analisi.
I MIGLIORI FILM DEL 2020
Come ogni anno, all’inizio di quello nuovo pubblico la classifica dei migliori film dei dodici mesi passati. Si tratta di una top 20, con alcuni “posti caldi” utili per misurare la bontà artistica di ciascuna annata – questa volta ovviamente condizionata dal Covid-19. I titoli presi in considerazione hanno avuto distribuzione ufficiale in Italia tra 1 gennaio e 31 dicembre 2020, in sala (pochi) su piattaforma (tanti) e anche in Blu-ray/DVD, purché inediti. Non entrano in classifica film visti ai festival o comunque non distribuiti. Dunque la datazione di alcuni dei film, anche quando è precedente, segue la distribuzione su territorio nazionale. L’ordine è dal numero 20 al numero 1. Si raccomanda di leggere anche le schegge dopo la classifica.
I MIGLIORI DEL 2020
Posti caldi: Elegia americana, Little Joe, Semina il vento, Sound of Metal, The Vast of Night
20) I’m Your Woman
19) Cosa sarà
18) The Lighthouse/Vitalina Varela (ex aequo)
17) Il processo ai Chicago 7
16) Il re di Staten Island
15) Ex-aequo tutti i film di Herzog distribuiti nel 2020 (Herzog incontra Gorbaciov, Nomad, Fireball e Family Romance LLC)
14) Le sorelle Macaluso
13) Richard Jewell
12) Dragged Across Concrete
11) Wolfwalkers
10) Favolacce
9) Diamanti grezzi
8) Volevo nascondermi
7) La ragazza d’autunno
6) Soul
5) La vita nascosta – Hidden Life
4) Tenet
3) Varda by Agnès
2) L’uomo invisibile
1) Ema
Schegge di cinema (tra i film non in classifica):
Craxi che canticchia Garibaldi fu ferito in Hammamet, i titoli di testa di Jojo Rabbit, la scenata con vomito finale di Gary Oldman in Mank, tutto il viaggio in auto iniziale di Sto pensando di finirla qui, il cranio di Kristen Stewart in Underwater, il suono delle bombe in Alla mia piccola Sama, i cori ultras di Ultras, i piani-sequenza di Tyler Rake, le pantofole di Tom Hanks in Greyhound, il drone di I miserabili, gli scontri a fuoco di Da 5 Bloods, il primo bacio di Mathias & Maxime, la lentezza in Galveston, il discorso alla Sinagoga di Borat 2, i ristoranti di On the Rocks, la luce del sole in Shadows, Hugh Grant in The Gentlemen, le gocce di sangue senza gravità in Midnight Sky, il freddo in Natale in casa Cupiello, il sesso in Siberia, le case popolari di Roubaix, Andrea Roncato in Sotto il sole di Riccione, Scamarcio che imita Banfi in Magari, le birre in freezer di Tornare a vincere…e mille altri baluginii….
TORINO FILM FESTIVAL 2020 – SECONDA PARTE
Seconda e ultima incursione nel TFF 2020, interamente online su MyMovies. Ancora una volta mi sembra che i generi e le riflessioni sul cinema siano state le cose più interessanti della selezione. Il territorio più vivace, come previsto, è stato la sezione Stanze di Rol, dove si sono aggiunti titoli particolarmente sorprendenti. Il primo di questi è Funny Face di Tim Sutton, che mi aveva decisamente irritato con Dark Night, pieno di allusioni e inconcludenze, giocato sui prodromi di una strage fuori campo; questa volta la dimensione della solitudine si impone grazie a un lavoro sulla rappresentazione urbana straordinario, e a posteriori dona qualche interesse in più anche al precedente, continuando una sorta di discorso sulle scorie suburbane dell’immaginario eroistico, e diventando di fatto una lacerante riflessione su New York (il monologo in automobile sui Knicks è da antologia).
Sempre in questo spazio, una certa simpatia suscita The Oak Room di Cody Callahan, post-noir a racconti incastrati, che piace per come sfrutta un budget quasi “zero” e la riflessione sul narrativo. Siamo dalle parti del postmoderno anni Novanta (non ci saremmo affatto stupiti di trovarlo a un TFF di un quarto di secolo fa) ma ciò non vuole dire che siamo fuori tempo massimo: in fondo il recupero di quelle forme meta-testuali e meta-genere può cominciare serenamente ad essere considerato retro-gusto di qualità.
E finiamo la sezione con Philosphy of Horror, certamente il più originale: Péter Lichter e Bori Máté si ispirano al famoso testo di Noel Carroll e lo trasformano in una ricerca visuale più simile a un intervento artistico che a un video-essay, di cui comunque assume alcune posizioni critiche lavorando sulla grana di due film della saga di Nightmare. A suo modo un found footage con scarabocchi e scratch che può abitare contemporaneamente nell’archeologia nei media, nell’analisi accademica dei film o nel dadaismo amatoriale.
Sempre di genere parliamo con l’omaggio a Carlo Ausino e il ritorno di un film non rarissimo (c’è anche su YouTube, per dire) ma tosto come Torino violenta. Circondato da una disistima critica poco giustificabile, rivisto oggi si conferma un poliziottesco di rovinoso nichilismo, con un’aria rozza e quasi punk che lo scenario urbano esalta. Assolutamente godibile. E visto che al TFF abbiamo visto un po’ di tutto, non è mancato nemmeno il porno. D’autore s’intende; anzi d’autrice, visto che Un dernière fois è diretto dalla militante dell’X-Rated femminista come Olympe de G., che recupera una star dell’erotismo ora ultra 65enne, Brigitte Lahaie, e la rende protagonista di un discorso tra eros e thanatos sulla sessualità in vecchiaia. Non ho mai ben capito come si deve fruire un porno intellettuale, ma sicuramente in questo caso entrambi i termini sono esplorati fino in fondo.
Delle altre visioni massicce e un po’ trafelate voglio ricordare giusto Camp de maci di Eugen Jebeleanu, ennesima conferma del cinema rumeno (che evidentemente si autoalimenta anche grazie allo stimolo reciproco tra cineasti), dove tutto si svolge in una sala cinematografica. Il tema è l’omosessualità repressa di un poliziotto che interviene per una violenta protesta omofoba che sta avvenendo in un cinema. La sala è un pretesto? Fino a un certo punto.
Infine, anche se aspettiamo di vederlo su grande schermo (viva lo streaming ma a tutto c’è un limite), segnaliamo la presenza del restauro 4K di In the Mood for Love. La riedizione è stata realizzata dal laboratorio l’Immagine Ritrovata di Bologna e da Criterion, con la supervisione del regista cinese e della colorist Calmen Lui che già nel 2000 fece la posa del negativo originale. Come sempre per tutto quello che fa Wong, anche il restauro è durato un sacco, oltre cinque anni, e sarà distribuito in Italia da Tucker Film all’interno di un progetto più ampio dedicato a Wong Kar-wai che prevede anche i restauri di Hong Kong Express, Fallen Angels e Happy Together distribuiti sempre dalla stessa casa.
TORINO FILM FESTIVAL 2020 – PRIMA PARTE
Molto importante la selezione che TFF ha messo in piedi per la versione integralmente online del festival, una manifestazione pensata per essere almeno in parte svolta in sala e poi bloccata dal decreto che ha chiuso le sale cinematografiche. Essendo uno dei festival italiani più “esperienziali”, nei quali almeno tre generazioni di cinefili hanno racconti e ricordi legati a quei portici e a quel centro storico (ma non solo), la versione in streaming non può che suscitare dibattiti sul suo svolgimento. Ma è ovvio che l’augurio è che si tratti di una sola, irripetibile, edizione.
Intanto, però, gli accreditati e gli abbonati hanno di fronte un’offerta davvero sorprendente e piena di anteprime. Il sottoscritto ha cercato (lo ribadiremo nel secondo pezzo dal festival) di pescare le cose più intriganti a partire dai contenitori. Quindi quasi nulla del concorso – che meriterebbe tempo e concentrazione che chi scrive non possiede – e invece via libera alle sezioni collaterali, a cominciare dalle Stanze di Rol, dedicato a generi ed emozioni forti, curata da Pier Maria Bocchi. Qui si vedono cose varie e decisamente divertenti: il molto chiacchierato horror The Dark and the Wicked di Bryan Bertino (che si conferma un creatore di atmosfere malate e inquietanti ma un mediocre scrittore, specie dei terzi atti e dei finali), il prevedibile Lucky psico-thriller “stalking” di Natasha Kermani, il simpatico Fried Barry di Ryan Kruger (versione sordida e fisiologica del Fratello da un altro pianeta di John Sayles), Breeder di Jens Dahl, ritorno non irresistibile del torture porn con qualche sorpresa nella psicologia della protagonista.
Ma il genere è presente di infilata anche in altre zone del programma, come nel caso di Calibro 9 di Toni D’Angelo, che si ispira direttamente al quasi omonimo capolavoro di Fernando Di Leo e prova a testare il funzionamento del poliziesco urbano italiano nell’estetica contemporanea – con risultati alterni, e una sensazione di gioco più che di adesione profonda. E il ritorno in versione finalmente integrale di Avere vent’anni proprio di Di Leo è un piacere. Il film si conferma ancora oggi “ingestibile” e probabilmente irricevibile nel contesto ideologico di oggi. Da una parte la libertà sessuale di Gloria Guida e Lilli Carati è un correlativo oggettivo dell’UFO cinematografico di Di Leo, dall’altra il finale sensazionalistico, programmatico e sadico sinceramente non deve piacerci per forza solo per motivi di cinefilia da “kings of the B”.
Nella sezione in cui era ospitato – “Back to Life” – si vedono chicche eccezionali, come la grande sorpresa del festival per quanto mi riguarda, Il nero di Giovanni Vento. Non solo un film intriso di new american cinema e di incredibili cortocircuiti tra estetica cassavetesiana e realismo sociale italiano, ma anche un documento storico per la presenza così anticipata e sentita di attori e personaggi neri di seconda generazione. Strepitoso, se ne dovrà parlare a lungo, possibilmente non solo ai convegni sul post-colonialismo e la diversity.
La produzione italiana oscilla decisamente. Film di registi perbene come Francesco Lagi sono intimisti fino all’impalpabile (Quasi Natale), altri sono commoventi per il cuore cinematografico che ci viene buttato dentro (il ritorno viscerale di Antonio Capuano con Il buco in testa), molti documentari sono legati agli anni della contestazione (certamente 1974 1979 che per una volta dà voce alle vittime del terrorismo, ma anche a modo suo l’avvincente doc su Goffredo Fofi e la sua avventura intellettuale, ancorché inspiegabilmente girato in bianco e nero nelle parti di intervista casalinga) o di esplorazione antropologica (per i bolognesi immancabile San Donato Beach di Fabio Donatini, tra malinconia bruciata dal caldo e repertorio di musica italiana usato in felice contrappunto alle stramberie post-industriali del quartiere multi-etnico).
Poi ci sarebbe da parlare di Paul Vecchiali (salutato da applausi udibili persino online, forse un filo esagerati ma guadagnati sul campo), o di Cecilia Mangini (chi aveva potuto già vedere Due scatole dimenticate ne conosce l’emozione) ma il tempo è spirato. Altra infornata a breve.
FESTIVAL DEI POPOLI 2020
Anche lo storico appuntamento fiorentino, diretto da Alessandro Stellino e curato da un comitato di selezione di alta qualità, si è spostato online e il sottoscritto ne ha spudoratamente approfittato (come in molti altri casi di quest’anno) per poter vedere e analizzare una manifestazione che per motivi di lavoro negli ultimi anni era stato quasi impossibile visitare.
Posso subito affermare che la selezione, almeno per i campionamenti e i carotaggi che mi sono potuto permettere (il festival va fino al 22 novembre, scontando una problematica sovrapposizione con TFF), si è rivelata di ottimo valore. Anche le sezioni si sono dimostrate al tempo stesso ben identificate e duttili. Pensiamo a “Let the Music Play”, dedicata al rapporto tra musica, cultura e società, dove si sono visti film ottimi come Sisters with Transistors di Lisa Rovner, appassionato studio pieno di documenti visivi e sonori dedicato alle pioniere della scena elettronica (voce over di Laurie Anderson) o Patti in Florence di Edoardo Zucchetti con Patti Smith e il suo rapporto con Firenze, artistico, affettivo e creativo. Ma di musica parla anche uno dei migliori titoli in assoluto di questa edizione, Medium del grande scrittore e regista argentino Edgardo Cozarinsky, che pedina e racconta l’amica pianista 93enne Margherita Fernández, raccontando al tempo stesso un’amicizia, una vocazione artistica, una storia politica e un partito preso di come si rappresenta (in modo fisso e senza stacchi) una performance classica.
E c’è musica anche in L’armée rouge, cinema del reale dedicato alla scena musicale ivoriana nel mondo dei migranti di Napoli (cinema del reale “allo stato brado” – come ha scritto uno spettatore a commento – è anche Aylesbury Estate di Carlotta Berti, dove però stranamente la grama storia di alcuni inquilini di co-housing popolari di Londra e dell’impari lotta contro gli speculatori del mattone appare troppo legata alle modalità standard di scrittura e messinscena del doc sociale contemporaneo).
Ovviamente il cinema presentato ai Popoli vale come osservatorio socio-etnologico di un mondo sempre più complesso e sempre più emarginato, con una divisione netta tra storie di persone raminghe loro malgrado e storie di persone che cercano di cambiare vita o di fare scelte alternative (le meno interessanti, sinceramente). Più drammatica la situazione quando i personaggi dei film non ci sono più, come l’umanissimo Massimiliano di Il libro di Giona (di Zlatolin Donchev): un uomo che vive in un’automobile ferma a ciglio delle strade, quasi aspettando la fine, che poi arriva prima di poter vedere il (forte) film su di lui finito.
La proposta è amplissima e i titoli esplorano terre anche molto lontane tra di loro. Ben poco unisce Look than Below dello sperimentalissimo Ben Rivers, sempre più antropologo lisergico e cineasta delle forme, e film come L’occhio di vetro di Duccio Chiarini, magari un po’ semplice nel racconto ma forse molto utile per capire i rimossi – talvolta laceranti, specie in ambito famigliare – del fascismo dei repubblichini in Italia.
Oltre al cinema del reale, ci sono naturalmente altri modelli, che talvolta funzionano più adesso che vent’anni fa, come quello di Wiseman che sembrerebbe guidare le scelte di Laura Lamanda in L’ile des objets dove però sembra quasi che la regista abbia avuto una grande idea (guardare al banco degli oggetti smarriti come a una istituzione quasi narrativa che raccoglie le sbadataggini e le perdite di un’intera umanità) ma poi non si sia ritrovata un vero sviluppo in mano. E lo stesso vale per Bulletproof di Todd Chandler, che racconta le strategie difensive dei licei americani per difendersi da eventuali attacchi da parte di alunni armati: uno spaccato raggelante e sorprendente, qua e là ripetitivo.
Ovviamente c’è anche spazio per il cinema, per esempio con il ritorno di Tigrero -A Film that Was Never Made di Mika Kaurismaki, 1994. Un film su un film mai realizzato (da Sam Fuller), un doppio viaggio per location inutilizzate, un discorso memoriale su lacerti cinematografici girati e mai conclusi, e sulla memoria di una comunità semi-civilizzata quarant’anni dopo il primo progetto.
PORDENONE DOCS FEST – LE VOCI DELL’INCHIESTA 2020
E anche l’intensissimo festival di Pordenone si avvia alle sue ultime ore, dopo un’edizione in streaming con una scelta diversa dalla maggioranza degli altri, cioè offrire i film a pagamento su una piattaforma dedicata con una serie di incontri e approfondimenti gratuiti, e un rapporto privilegiato con le audience studentesche. Si tratta di una manifestazione molto cresciuta negli anni, oggi dotata di un gran numero di anteprime nazionali e di una selezione documentaria decisamente di livello.
Nell’offerta al solito molto ricca e densa dei festival novembrini che abbiamo cercato di seguire, Le voci dell’inchiesta coglie nel segno soprattutto nelle linee interne alla selezione. Pensiamo, per esempio, al tema del fascismo. Oltre alla sempre benemerita riproposizione di capisaldi come All’armi siam fascisti e Pays Barbare – in qualche modo già pienamente nella storia del documentario militante e del documentario sperimentale d’archivio – nel programma (visibile solo in chiusura e senza repliche) spicca la nuova versione digitale di Fascista (1974) di Nico Naldini, film raro e perduto.
Il tema del fascismo, però, si affaccia anche nelle novità, a cominciare dall’appassionante studio – pieno di documenti cartacei, iconografici e fotografici – All Againist All di Luuk Bowman, in cui si ricostruisce meticolosamente la parabola del fascismo olandese, tutt’altro che nota persino all’interno della storiografia nazionale (la vulgata del singolo partito fascista collaborazionista con l’occupazione nazista viene smentita dall’attività editoriale e propagandistica di molti gruppuscoli e movimenti nazionalisti e filo-mussoliniani degli anni Trenta).
E c’è spazio anche per il neo-fascismo, o per il sovranismo se si preferisce. L’ottimo La cravate di Étienne Chaillou e Mathias Théry narra senza pregiudizi la vita quotidiana di un giovane militante di provincia del Front National di Marine Le Pen. Narrato come un personaggio di finzione che riflette sulla stessa narrazione che gli autori scrivono per lui, il documentario ha il merito di spiegare il tessuto sociale frustrato e piccolo borghese del nazionalismo lepenista, e l’apparente “normalità”, talvolta anche carrierista, dei giovani candidati in cravatta delle piccole città francesi. Impressionante, però, scoprire che il protagonista ha quasi portato a termine il progetto di una strage scolastica, per poi pentirsi e “assorbire” la sua rabbia nel Front National.
Non c’è spazio per citare tanti altri titoli – dagli struggenti omaggi ai propri genitori colpiti dalle malattie di almeno due film (The Journey e Our Time Machine) ai documentari sul cinema (acuto e utile lo scavo sul documentario sexy di Mario Sesti in Mondo Sexy) – ma la percentuale di opere interessanti sul totale è decisamente rimarchevole.
Archivio aperto 2020
Pressoché impossibile riuscire a riassumere il programma torrenziale e a dir poco entusiasmante che i curatori di Home Movies – Archivio Nazionale dei film di Famiglia hanno messo in piedi quest’anno per la prima edizione integralmente online del loro “festival”: tra virgolette perché si tratta di un’esposizione allungata, di una esibizione di materiali a lento rilascio, che si possono godere con calma fino al 6 dicembre, gratuitamente su MyMovies o sul sito ufficiale. Devo dire che il sottoscritto ha optato per il contrario, due-tre sessioni potentissime e micidiali, di varie ore, in cui immergersi nel profluvio di materiali d’archivio, documentari, home movies, film sperimentali, film amatoriali, e tutto l’universo memoriale e non ufficiale che viene coinvolto da questa iniziativa.
Se ai cinefili e ricercatori più attenti il monumentale Diary di David Perlov non era sconosciuto (ma vederlo tutto insieme, ben diviso nei suoi capitoli, su un device digitale, ha un suo nuovo e conturbante perché), altre cose ci hanno profondamente sorpreso. Vitalissima, al solito, la sezione Art & Experimental Film, dove a un bellissimo Bacigalupo (Quasi una tangente, di un erotismo e di una libertà unici), si affiancano i per me meno noti lavori di Andrea Granchi, Fernando De Filippi o Gianni Castagnoli, tutti significativi per l’epoca e non solo. Discorso a parte il meta-artistico e auto-ironico Shaping Negation di Arnaldo Pomodoro, Ugo Mulas e Francesco Leonetti, una delle opere più interessanti sulla distanza critica, sia pure paradossalmente condita di profonda serietà e consapevolezza artistica, rispetto al proprio lavoro.
Per i “cine-eccentrici” spazio al bolognese Mauro Mingardi, già glorificato da un recente documentario, Un western senza cavalli diretto da Davide Rizzo e Marzia Toscano, realizzato in collaborazione proprio con Home Movies. Mingardi ha realizzato oltre quaranta film tra corti e lungometraggi, autarchico vero, facendo tutto da solo, con gli amici come attori, tra anni Sessanta e Ottanta. Bottega amatoriale strepitosa, macchina-cinema singolare e irriducibile, la filmografia 8mm e Super8 di Mingardi esplora molti generi: nella scelta proposta principalmente il noir, con lasciti evidenti da Hitchcock (e qualche anticipazione depalmiana prima di De Palma), da Clouzot, da Chabrol, dal gotico italiano, forse persino da Feuillade, sempre con ironie che talvolta restano sotto traccia per far spazio al perturbante e talvolta esplodono con anarchia.
Un po’ come i ragazzi dei sobborghi di New York, Rob Niosi e i suoi amici (Ron Bucalo e Nicola Scaramozzino) che da ragazzini usano le cineprese dei genitori per fare spoof e parodie di horror e fantascienza usando ogni tipo di trucco e di inventiva, tra Méliès e il primo Landis (ma fors’anche ricordandoci i corti di Spielberg). Nel programma Famtastic Stories vediamo alcuni di questi esperimenti (ritrovati di recente e realizzati negli anni Settanta), che in fondo anticipano anche in questo caso certe estetiche contemporanee come quelle dell’amatoriale trasportate nel mainstream, in particolare Michel Gondry.
Altre belle cose arrivano dalla sezione Recycled Cinema (un Luca Ferri “found footage” e Beatrice Baldacci con il commovente viaggio nella memoria VHS della madre in Supereroi senza superpoteri) o dalla sezione Archive Bites, nel quale abbiamo trovato un raro filmato di Gianni Rodari in visita alla Scuola dell’Infanzia Diana nel 1972 nel Comune di Reggio Emilia dove racconta e si fa raccontare con grande tenerezza favole per l’infanzia (e cos’altro, del resto?).
Il programma avrà ulteriori aggiunte tra fine novembre e inizio dicembre.
RAVENNA NIGHTMARE FILM FEST 2020
C’è un’anima sempre più sperimentale nel Ravenna Nightmare Film Fest, anch’esso esclusivamente in versione online per l’edizione 2020. Non più confinato al solo genere horror e dintorni, ma sempre più interessato anche agli spazi inclassificabili del cinema d’autore e delle poetiche del corpo o del surreale, il Nightmare (lo chiamiamo così per brevità) sta offrendo un programma composito e pieno di sorprese, anche nei formati brevi.
Nel Nimic di Yorgos Lanthimos, per esempio, c’è la voglia del regista greco di tornare nei territori originari, anche se la progressiva de-territorializzazione del suo cinema lo ha da tempo spostato in una zona franca internazionale (Hollywood a parte) fatta di umori sospesi tra Haneke e Saramago. Nella storia di un Matt Dillon espropriato del suo ruolo di capo famiglia da una ragazza che pretende di sostituirlo “come padre e come marito” tutti i paradossi di Lanthimos vengono fuori in poco più di dieci minuti, con risultati misteriosi ma degni di essere discussi.
Diversamente, l’esperimento di Bertrand Mandico (The Return of Tragedy) è assai più irritante, una di quelle cose accumulatorie e cinefile dove sembra quasi obbligatorio che lo spettatore si diverta e ne parli bene. Nient’affatto: il mix di cinema amatoriale, No Wave, avanguardia e horror di serie Z mi pare del tutto irrilevante, e mi stupisce l’entusiasmo di cui è circondato. Molto meglio, invece, i corti di Donato Sansone, tra clip e animazione o i lavori di Koji Yamamura, dal tratto semplice e dalla forza filosofica intrigante.
Interessante anche lo sfruttamento dello spazio festivaliero per l’approfondimento critico o le lezioni speciali, come quella di Andrea Chimento su David Lynch. Invece, spizzicando qua e là nel concorso, colpisce tra i tanti titoli (diseguali, come del resto è inevitabile che sia) Woman of the Photographs di Takeshi Kushida, dove la storia di un ritocco fotografico orrorifico e di un rapporto tra artista e modella, invece che sortire un effetto di prevedibile déjà-vu di temi e tropi, trova strade intense e tutto sommato spiazzanti. Sorprendente, perché al solo sentir parlare di riflessione sul corpo e sull’immagine c’era da tremare.
Per il resto, festival come questo da una parte confermano come l’occulto e il perturbante siano griglie attraverso le quali una grande quantità di cinematografie nazionali può affrontare, interpretare, trasfigurare un presente complesso e nodi socio-culturali al tempo stesso singolari e universali. Dall’altra rinfocolano la sensazione che là fuori, nella produzione globale sempre più frenetica di storie e di opere, ci sia sempre più bisogno dei festival come agenti curatoriali e di selezione. Che la fisionomia del Nightmare stia cambiando, insomma, è segno di intelligenza.
Science + fiction 2020
Dopo i tanti tira e molla nazionali e regionali sulle sale cinematografiche e la loro capienza, il dpcm di ottobre che ha chiuso definitivamente le sale ha stroncato ogni possibilità di festival in presenza o anche solo ibridi. I molti festival italiani di novembre (davvero tanti) traslocano tutti online, la maggior parte su MyMovies – che diventa una sorta di fornitore leader di media events legati al cinema.
Inutile ora riaffrontare la difficile questione dell’essenza del festival online, anche perché curiosamente coloro che l’hanno contestata sono stati quelli che sono riusciti a organizzarlo o prima della pandemia o nel periodo tra prima e seconda ondata. Il Trieste Science+Fiction Festival– luogo quasi mitico della fantascienza italiana, anche per il legame ancestrale con la sua precedente versione, epocale, degli anni d’oro – si svolge dunque tutto su piattaforma.
Lo dico subito, non mi è possibile per nessuno di questi festival seguire dettagliatamente tutto il programma e tutti i film. Non lo potrebbe fare nemmeno chi fa esclusivamente il critico, vista la simultaneità dei tanti appuntamenti, ma ancora meno chi ha come primo mestiere quello di accademico (natura che peraltro si intreccia e fonde alla pratica critica, nel mio caso). Tutto questo per dire che Trieste, anche solo assaggiando parte della proposta, mi dà l’impressione di un festival in grande salute, grazie alla solida direzione di Daniele Terzoli e a uno staff di collaboratori esperti, giovani e meno giovani, che sanno selezionare tante cose belle.
Quest’anno, pur cominciando con il “generaccio” caotico di Skylin3s – terzo capitolo di una saga di cui non si sente alcun bisogno – si sono presto rivelate altre storie interessanti. Per esempio si conferma la tendenza allegorizzante dell’horror contemporaneo: Relic di Natalie Erika James è un film che rappresenta la malattia dell’Alzheimer trasfigurandola come un viaggio haunting in luoghi oscuri e paurosi che diventano una minaccia anche per la famiglia (tutte donne: nonna, figlia, nipote, come a dire che l’accudimento dei malati spetta sempre alla discendenza femminile). Un Babadook della terza età, con meno originalità ma momenti molto toccanti (altri non di ottimo gusto, visto il tema, ma tant’è).
La fantascienza politica con risvolti sociali, a sua volta, sembra coprire ormai buona parte del territorio. Lapsis di Noah Hutton, pur penalizzato dal basso budget e da attori non particolarmente carismatici, e pur evidenziandosi come un episodio allungato di Black Mirror, appassiona per come costruisce un mondo parallelo in cui l’automazione della gig economy è arrivata ad estremi devastanti. Interessante e paradossale l’intreccio tra mondo completamente digitalizzato e background fisico dello stesso, con i precari del lavoro privato costretti a cablare faticosamente mezzo mondo per farlo funzionare.
Ovviamente quel che interessa del Trieste Science Plus Fiction è anche l’apertura geografica alle produzioni internazionali, anche le più inattese come il potente horror Post Mortem di Péter Bergendy, ungherese, ambientato nel 1918, legato al tema del fantasma, della fotografia e del ritratto mortuario. Anche qui le istanze metaforiche (prima guerra mondiale, Spagnola, folklore, comunità ecc) si sprecano, ma con cura formale non scontata e momenti seriamente inquietanti.
Un festival sempre appassionante, in ogni caso. Complimenti.
COLONIZZARE LA LUNA (E NON SOLO)
Questa volta recupero un piccolo contributo scritto in occasione dei 50 anni dell’allunaggio, scritto per la pubblicazione (scaricabile qui) della Cineteca di Bologna, a cura dell’Associazione Schermi e Lavagne, intitolata Destinazione Luna. Il tono è ovviamente divulgativo ma mi fa piacere sottoporlo al lettore.
Colonizzare. Parola che riporta alla mente un passato della storia contemporanea poco commendevole. C’è persino una branca di studi accademici che si chiama “studi post-coloniali”, che intende definire i rapporti tra occidente e luoghi de-colonizzati rispetto alle varie soggettività che sono nate dopo il periodo di riferimento. Nel cinema di fantascienza, non è raro che sia stata la Terra – forse per pagare il fio di tante ingiustizie – a diventare obiettivo di una colonizzazione, come nel caso del sempreverde L’invasione degli ultracorpi, baccelli extraterrestri pronti a copiare le nostre fattezze (il copyright del corpo, in fondo) per sostituirsi. D’altra parte, che cosa voleva fare Jake Sully, il marine di Avatar, se non infiltrarsi nel corpo di un abitante del pianeta Pandora per facilitare invasione e distruzione di una civiltà? Poi nel corso del film, per fortuna, ha cambiato idea.
La conquista della Luna pone senz’altro meno problemi umani, per l’assenza di popolazione. Non per questo l’approccio appare sempre positivo. In Transformers 3 la faccia nascosta della Luna cela comunque molti segreti, ma senza scomodare l’immarcescibile complottismo su quanto avvenuto nel 1969; l’essere umano basta da solo a mettersi nei guai. A volte generando altri se stessi, e non per allusioni pirandelliane (che pure funzionano da suggestione per i cinefili italiani): in Moon l’astronauta sulla base lunare amerebbe soffrire di solitudine pur di non veder arrivare una sua copia sputata, un sosia che cambia la percezione del mondo e del mercato, visto che l’ultima frontiera del capitalismo (come spiegato già da Blade Runner nel lontano 1982) è trasformare il corpo umano in forza lavoro artificiale, replicabile.
D’altra parte, la Terra rimane sempre un luogo problematico. In Wall-E gli uomini in fuga dal proprio pianeta inquinato, che hanno contribuito a prosciugare di vita, si ritrovano su una colonia vagante, dove non hanno altro da fare che rimanere per sempre consumatori, seduti su poltrone e ormai privi di forza fisica, rotondi come un Botero. Invece in Interstellar, il problema dell’inquinamento (vera e propria ossessione del cinema di fantascienza, insieme all’apocalisse nucleare) suscita interrogativi più tecnici. Che si voglia colonizzare un altro pianeta, è fuori di dubbio. Ma quale? E come si trasporta la forza di gravità? Quando il protagonista si infila in continui cunicoli spazio-temporali è perché l’ossessione dello spazio è fin troppo spesso considerata in maniera pre-galileiana. Non a caso nel 1902, Méliès, nella prima scena di Voyage dans la Lune, mostrava un consesso di scienziati in cui il più visionario tracciava su una lavagna una normale traiettoria a trattini. Dalla Terra alla Luna. Senza tenere conto del tempo, che è curvo e complicato ancor più dello spazio con cui interagisce, suscitando – come in Nolan – non solo grandi domande sul futuro dell’umanità ma anche sulla narrazione cinematografica.
Tra le colonizzazioni più credibili degli anni recenti c’è sicuramente The Martian di Ridley Scott. Si tratta, notoriamente, del film che analizza nel modo più realistico possibile che cosa potrebbe succedere quando andremo davvero su Marte. I guai dell’astronauta, primo colono, vengono risolti dall’abnegazione dell’uomo americano per eccellenza, interpretato da Matt Damon, che grazie alle sue capacità di agricoltore e di homo faber, sopravvive in ambiente ostile. Per molti critici, il bel film di Scott fa più parte del cosiddetto survival (sottogenere dedicato alla sopravvivenza in condizioni estreme) che della fantascienza. E in effetti è stato esilarante scoprire che – intervistati per un’indagine – alcuni spettatori statunitensi si sono dichiarati convinti che The Martian fosse tratto da una storia vera. Dramma dell’ignoranza o potere convincente del cinema? Certo è che il sapore veritiero che Scott ha voluto trasmettere alla sua spedizione scientifica ci dice molto del rapporto tra immaginario filmico e progresso aero-spaziale e scientifico.
In fondo, tutti i film sulla Luna girati dopo il 1969 hanno trasformato la science fiction in Storia. E quando si torna a parlare di Luna – come in Il primo uomo – si enfatizza l’aspetto meccanico e pre-digitale dell’impresa, quasi a confermare che quella conquista è stata stupefacente e coraggiosa. Non abbiamo colonizzato nulla, anzi sulla Luna non ci siamo nemmeno tornati. Ma la lezione per il cinema è stata incalcolabile, tanto da aver nutrito buona parte di questo genere, in epoca moderna e contemporanea.
“i giorni della vita” e il morality play
Il film è tratto da una pièce di William Saroyan, importante scrittore e drammaturgo americano, che per questo suo lavoro ha vinto alcuni dei più prestigiosi premi internazionali. Nel 1948, al momento di produrne la versione cinematografica, Saroyan era uno dei più quotati artisti del paese. Per questo motivo, sul film si è puntato molto, allestendo un cast di eccezione. Il ruolo di protagonista – meglio sarebbe dire di narratore o di arbitro della lunga galleria di personaggi – è infatti James Cagney. Tutt’intorno, caratteristi di prim’ordine, che molti appassionati di classico hollywoodiano riconosceranno per averli visti in decine di film, soprattutto di genere western: Ward Bond, Broderick Crawford (che girerà anche con Fellini, Il bidone, 1956), William Bendix, Wayne Morris.
I critici americani hanno definito il film un “morality play”, con ciò intendendo un dramma dalle profonde valenze etiche e civili. Il “morality play” è una tradizione settecentesca anglosassone che si è trasferita con originale dinamismo nella cultura teatrale americana. I personaggi di questi drammi sono portatori di concezioni differenti della vita sociale, e vengono destinati a un confronto serrato sulle proprie idee di vita e sui possibili modi di raggiungere la felicità. La tendenza alla riflessione sociale e all’insegnamento dei valori propria della cultura statunitense si trova anche in I giorni della vita. In questo film, tutto ruota intorno al Nick’s Saloon, un albergo ristorante frequentato da alcuni tipi fissi e da avventori occasionali. Tra di loro, c’è un po’ tutta l’America che si arrangia nella vita: piccoli truffatori, showmen in cerca d’ingaggio, ragazze dal passato poco raccomandabile, ricattatori e malavitosi, ma anche molte persone pulite, che cercano semplicemente di riscattarsi da una vita difficile.
Vista l’origine del testo, si può ben immaginare che gran parte della narrazione è affidata al dialogo e all’unità di luogo e azione. Scelta rischiosa, certo: tuttavia, quando la sostanza c’è – e in questo caso, in abbondanza – lo spettatore non risente di alcuna claustrofobia. Anzi, Time of Your Life è un film intellettualmente vivace, arguto, coinvolgente. La qualità dei dialoghi, molto fedeli al testo originale, è altissima. I personaggi sono uno più riuscito dell’altro: basti pensare alla figura dell’anziano “Buffalo Bill” che rappresenta simbolicamente tutto il passato degli Stati Uniti, quello dei pionieri e del mito. Ma anche il personaggio femminile, che afferma di aver viaggiato in lungo e in largo con una compagnia di varietà, dice qualcosa sull’intreccio di verità e finzione tipico della grande terra dei sogni, l’America.
Non si deve pensare che I giorni della vita sia un film solare. Lungo tutta la durata della pellicola, il tono è malinconico, intervallato da continue performance, canzoni, monologhi, esternazioni, crisi. Ognuno dei protagonisti ricava il proprio momento espressivo. In questi casi, il resto del cast diventa una sorta di pubblico muto, di spettatore della personalità altrui. Come per molti altri film presentati in questa stessa collana, la recente tragedia bellica aleggia sulla scena più di quanto non si pensi. Il cinema classico hollywoodiano, infatti, ancorandosi a codici e linguaggi solidi e riconoscibili, appare meno penetrabile agli eventi – anche traumatici – della realtà storica. In verità, i lutti e le glorie del secondo conflitto mondiale hanno lasciato il segno.
Il secondo dopoguerra è un periodo di assestamento per tutta la società statunitense. Si moltiplicano, in questi anni, i film che – in forma metaforica – riflettono sulla comunità, sul concetto di convivenza, sulla sensazione che una nuova, matura concezione del vivere insieme sia a portata di mano. I giorni della vita è uno dei film che risente del clima di questo periodo. Nel microcosmo narrativo di Saroyan, infatti, si può in filigrana scorgere una tipologia di società, una visione umana e comprensiva delle debolezze umane e degli errori quotidiani.
Dal punto di vista stilistico, il film presenta molti tratti di interesse. La macchina da presa denuncia continuamente la sua presenza, grazie a movimenti molto elaborati e a scelte inconsuete di rappresentazione dello spazio. Spesso, il personaggio che parla è inquadrato in modo da permettere di osservare ciò che avviene dietro di lui, in profondità di campo. Il bar dove si svolge la vicenda, poi, è raffigurato da tutti i punti di vista, quasi che si intendesse donare allo spettatore la prospettiva di ogni personaggio. Il gioco dei chiaroscuri offre risultati di gran qualità, specie quando nella stessa inquadratura compaiono particolari composizioni visive. La direzione degli attori è ragguardevole, tanto che l’affiatamento decreta la riuscita dell’operazione.
Il responsabile di un così brillante esito è H.C. Potter, cineasta di grande esperienza, non alieno all’ambiente teatrale. Tra i suoi film più celebri, il musicale Follie di Jazz (1941), la sarabanda di Helzapoppin’ (1941), e il grande melodramma Addio, signora Miniver (1950), seguito del celebre successo di William Wyler del ’42. Potter è abituato alla dismisura e alle emozioni più eccessive (riso, pianto, comicità dell’assurdo, come anche in La casa dei nostri sogni, 1948). Qui, invece, mostra una sapienza registica inattesa, un rigore estetico da grande autore.
Il lavoro sugli attori è essenziale. James Cagney ha impersonato per anni il gangster intraprendente e carismatico destinato alla sconfitta (Nemico pubblico, 1931; I ruggenti anni Venti, 1939), poi – negli anni Quaranta – ha saputo ammorbidire i toni delle sue interpretazioni (Bionda fragola, 1941; Sposa contro assegno, 1941), senza mai dimenticare la grinta delle origini (La furia umana, 1949). Potter sembra infatti incaricare Cagney del ruolo di “pivot”, per usare una metafora cestistica. Proprio lui, infatti, commenta gli avvenimenti in voce fuori campo, lui che offre la battuta agli altri personaggi, lui il perno intorno al quale girano gli altri attori: come se fosse al centro della scena per coordinare, da direttore d’orchestra, le interpretazioni dei suoi musicisti.
Con il volto schiacciato ma pieno di calore umano, il suo personaggio entra direttamente in azione solo nel finale, contribuendo a costruire un futuro migliore, se non per sé, almeno per le persone che ha imparato a conoscere. I giorni della vita è un piccolo grande film, che vale la pena recuperare e collocare nell’antologia dei classici.
“Ghosts on the loose” e i generi alla deriva nella hollywood popolare
La storia segreta del cinema americano è quella dei piccoli prodotti popolari, cuore pulsante del vero classico hollywoodiano e colonna vertebrale del consumo pomeridiano tanto nelle metropoli quanto nei centri più periferici. In questi film, di solito conditi di commedia, humor macabro, orientalismo esotico e avventura, non si trovano grandi star o finanziamenti di primordine. Tuttavia, molte volte la vocazione minoritaria di queste pellicole diventa sinonimo di freschezza di idee, libertà compositiva, piacere anarchico della messa in scena, originalità di contenuti. Ghosts on the Loose ne è esempio lampante. Troviamo un divo del cinema dell’orrore di un tempo – Bela Lugosi -, un regista specializzato in film popolari e bizzarri – William Beaudine -, un cast noto per far parte di una serie di pellicole buffe e scanzonate – i cosiddetti East Side Kids -, e un’Ava Gardner giovane e ancora non del tutto affermata.
Gli anni Quaranta, per il cinema americano, sono quelli di Gianni & Pinotto contro i mostri assortiti della Universal, quelli del musical di serie B, quelli della serie sulla Mummia, quelli degli Stooges e del comico demenziale ante litteram, quelli della “smalltwon life” tesa a rincuorare l’America di provincia in un contesto di guerra, insomma sono gli anni del cinema che parla a una nazione profonda e inquieta, e che cerca di intrattenerla con gli aspetti di uno show cinematografico non privo di interesse e caratteri inediti, almeno per gli appassionati e gli storici.
In questo contesto nasce dunque Ghosts on the Loose. Si tratta di un film curioso, che dimostra – tra le altre cose – come la fusione e l’ibridazione di generi diversi sia consuetudine nota già all’epoca classica, e non un’invenzione di Quentin Tarantino o dei fratelli Coen.
In questo caso, a darsi appuntamento per un incontro tra opposti, sono l’horror, lo spionistico e la commedia. Il primo genere è “convocato” dalla presenza stessa di Lugosi. Il volto di questo immigrato ungherese dal vero nome di Bela Blasko era già noto all’epoca del muto grazie al sodalizio con Tod Browning, che poi lo diresse nel celebre Dracula del ’31. Come da più parti è stato sottolineato, quel film diventò il trionfo e al tempo stesso la condanna di Lugosi, che venne impiegato in decine di pellicole – comprese quelle di Ed Wood che Burton ha celebrato, con Lugosi, in un delizioso film dark -, sempre negli stessi ruoli (con l’eccezione della parte secondaria offertagli da Lubitsch in Ninotchka, 1931). Già dagli anni Quaranta, Lugosi è Lugosi, interpreta cioè un personaggio ambiguo e soprannaturale ma gioca con il pubblico sul suo divismo di genere. Questo film, infatti, avrebbe in un primo tempo dovuto intitolarsi East Side Kids vs Lugosi, tale era ormai la fama del magnetico attore dalle folte sopracciglia.
Lo spionistico rappresenta invece la dimensione più “thriller” della storia. Infatti, l’impresa di pulizie dei East Side Kids si reca a sistemare la casa appena acquistata dall’amico in viaggio di nozze, per fargli una sorpresa. Per errore, però, i confusionari impiccioni finiscono tra le mura dell’appartamento a fianco, noto per essere abitato da fantasmi. I quali, però, non sono reali spettri, bensì trucchi escogitati da nazisti per tenere lontano gli indesiderati e sfruttare l’abitazione come covo per i propri loschi traffici. Un elemento propagandistico, sia pure annacquato in questo divertissement per famiglie, si aggiunge perciò agli elementi principali.
Infine, la commedia. Gli East Side Kids sono un po’ come gli Stooges – altri artisti assai poco conosciuti in Italia – senza la vena distruttiva e irriverente dei tre. I loro bersagli sono più a portata di mano, il loro umorismo più circense che dadaista. Tuttavia, Ghosts on the Loose è un documento importante per accorgersi di un cinema americano sempre in contatto con le novità provenienti dai palcoscenici, del vaudeville di città e del burlesque di provincia. Gianni & Pinotto, come i fratelli Marx, sono tra i modelli degli East Side Kids.
In fondo, Ghosts on the Loose fa prevalere la dominante comica. Si può affermare che si tratti di una parodia, anche se non esiste un bersaglio preciso. Ad essere ridicolizzato è piuttosto tutto il sottofilone delle case stregate. La spiegazione razionale ad avvenimenti apparentemente soprannaturali è un classico dei film sulle “haunted mansions” e riporta a una tradizione teatrale (il Tartufo), del cinema delle origini (The Cat and the Canard di Paul Leni), e letteraria (dal gotico al mystery).
Botole, scalinate, refoli di aria fredda, tutto l’armamentario spettrale viene sciorinato dai nazisti capitanati da Lugosi alo scopo di allontanare i nuovi arrivati. Eppure, come tradizione vuole, gli East Side Kids in fondo sono troppo stupidi anche per avere paura, per cui – sebbene spaventati a morte – finiscono col resistere stoicamente (e stoltamente). Alcune gag sono decisamente irresistibili: ad esempio, la sequenza del ritratto, dove Bela Lugosi inganna i presenti sostituendo il proprio volto a quello della nobildonna incorniciata, salvo poi starnutire a causa della polvere. Qui l’attore dà prova di grande autoironia, scherzando sull’impassibilità del proprio viso e lasciandosi dolcemente prendere in giro dai coprotagonisti.
Meno memorabile, la filmografia di William Beaudine è però un must per chiunque voglia conoscere il lato meno celebrato dello studio system classico. Come si diceva, Beaudine rappresenta quello spettacolo popolare e squisitamente “B movie” che viene utilizzato per il “double bill” (il doppio spettacolo) nei cinema dove si proietta un film di serie A, o che successivamente viene presentato nelle matinée cinematografiche piene di ragazzini urlanti. Titoli come Lo scrigno orientale, Il serpente piumato, Billy the Kid contro Dracula, o Jesse James incontra la figlia di Frankenstein spiegano molto meglio di qualsiasi analisi in che fantasioso, bambinesco terreno ci muoviamo e aprono scenari tra l’esotico e il fiabesco, animati da una voglia irrefrenabile di divertirsi con i miti moderni della celluloide.
Il soprannome di Beaudine era “One-Shot”, ovvero “una sola ripresa”, prova della sua rapidità nel girare e dell’esperienza maturata. E’ ad artigiani come lui che, a ben vedere, si deve la solidità delle fondamenta hollywoodiane. Solo grazie a film puliti e professionali come Ghosts on the Loose un’industria può poi sorreggere sforzi economici per i generi maggiori e per i cineasti più esigenti.
COLONNE DI CRITICA
Con colpevole ritardo parlo di un volume che mi è molto caro e che l’autore ha avuto la gentilezza di scrivere includendomi in alcune sue parti antologiche. Si tratta di Il cinema tra le colonne di Denis Lotti (Rubbettino Editore, 14 euro) ed è uno dei contributi più lucidi e comprensibili sulla critica cinematografica che siano usciti negli ultimi anni (e mi includo tra quelli che giungono più indietro, rispetto a Lotti, in questa classifica della chiarezza).
Come al solito, il volume lo facciamo presentare dai materiali editoriali virgolettati: “Da almeno un secolo, in Italia, coesistono esperienze eterogenee di critica cinematografica, che disegnano un percorso discontinuo tra passato e presente, tra stampa cartacea e Internet. Dopo un compendio di storia della critica, rivisitata dai pionieri sino ai giorni nostri, l’autore analizza metodi, forme e stili della recensione cinematografica prendendo in esame un ampio ventaglio di quotidiani, periodici, testate, blog e social network. In appendice è presente una antologia di testi scelti, esemplari della vivacità del dibattito italiano sul cinema dall’epoca del muto sino a oggi”.
Piace, del libro, la capacità di interconnettere i momenti della storia della critica cercando di farli dialogare e non per forza privilegiando la discontinuità e gli strappi rispetto al quadro generale. Forse è la forma mentis da storiografo e ricercatore (attento ai documenti più che alle speculazioni identitarie) dell’autore che distingue Il cinema tra le colonne da altri testi sulla critica, talvolta molto teorici o più versati sulla dimensione memoriale e manualistica (o meglio precettistica). L’esemplificazione antologica funziona a sua volta molto bene, ma è soprattutto nella ricostruzione del percorso della critica negli anni che il libro convince e appassiona, mantenendo la promessa del sottotitolo, ovvero spiegare “storia, metodi e luoghi” di questa tanto analizzata istituzione oggi assai fluida.
Pur essendo ben consapevoli che agli studiosi non è richiesto di amare il proprio oggetto di studio (che anzi talvolta è meglio maneggiare da amico o conoscente non stretto), si vede che Lotti vuole bene alla critica e alla sua storia. In questo caso, non nuoce affatto.
I tre sguardi di “elephant man”
Quarant’anni dal capolavoro di David Lynch. Il restauro, attentamente coordinato dall’Immagine Ritrovata, e in particolare da Davide Pozzi, insieme allo stesso Lynch (dalla California), ripropone il bianco e nero di Freddie Francis in maniera intensa e classicizzante.
Avendo avuto il privilegio di introdurre il film, ho proposto al pubblico questo dubbio. Che cosa sarebbe stata la carriera di Lynch se l’equilibrio trovato questa volta e la fiducia accordatagli da Mel Brooks si fossero ripresentate per tutta la carriera? Nessuno ovviamente vorrebbe cambiare la magnifica carriera di David Lynch, a cui del resto chi scrive ha dedicato libri e saggi, ma quarant’anni dopo viene la tentazione di immaginare un Lynch completamente hollywoodiano e come sarebbe stato il suo cinema se si fosse svolto sempre all’interno della produzione ufficiale.
In ogni caso, come in altri articoli dedicati al Cinema Ritrovato 2020, ospitiamo un pezzo d’epoca, saccheggiando il catalogo del festival, e stavolta tocca a Serge Daney (Cahiers du Cinéma, aprile 1981):
“Nel corso del film John Merrick è oggetto di tre sguardi. Tre sguardi, tre epoche del cinema: burlesca, moderna,classica. O anche: il baraccone, l’ospedale, il teatro. C’è innanzitutto lo sguardo dal basso, quello del popolino,e lo sguardo (duro, preciso, brusco) di Lynch su questo sguardo. Ci sono sprazzi carnevaleschi, nella scena in cui Merrick viene ubriacato e sequestrato. Nello spettacolo da baraccone non c’è un’essenza umana da incarnare (nemmeno sotto le sembianze di un mostro), c’è solo un corpo da schernire. Poi c’è lo sguardo moderno, quello affascinato del medico, Treves: rispetto dell’altro e cattiva coscienza, erotismo morboso ed epistemofilia. Occupandosi dell’uomo elefante Treves salva se stesso: è la battaglia propria dell’umanista (alla Kurosawa).
C’è infine un terzo sguardo. Più l’uomo elefante è conosciuto e festeggiato, più coloro che gli fanno visita hanno il tempo di costruirsi una maschera, una maschera di cortesia che dissimula ciò che provano vedendolo. […]Il finale del film è molto commovente. A teatro, quando Merrick si alza nel suo palco perché coloro che lo applaudono possano vederlo meglio, non si sa più precisamente cosa c’è nel loro sguardo, non si sa più cosa vedono. Lynch è allora riuscito a riscattare – l’uno attraverso l’altra, dialetticamente – il mostro e la società. Ma solo a teatro, solo per una sera. Non ci saranno altre rappresentazioni”.
Le gambe di henry fonda
Henry Fonda non sa bene dove mettere le gambe e per questo ha bisogno di spazio. Un uomo alto, magro, ma non impacciato. Gli piace sedersi e dondolarsi, qui e in famosi film successivi (primo fra tutti, Sfida infernale). In Alba di gloria è tutto un sedersi in posti improbabili, trovare uno strapuntino dove posare il sedere e trovarsi le ginocchia in bocca, camminare lentamente davanti alla corte di giustizia mentre interroga i testimoni, sdraiarsi appena può in un bosco o in un cortile. Il Lincoln che John Ford gli costruisce addosso ha poco dell’imitazione ritrattistica (anche se il naso posticcio di Fonda serve a ricordarne i noti tratti somatici) e molto dell’andamento dinoccolato e della prestazione corporea di un Fonda meraviglioso, al tempo stesso pigro e pugnace.
Come scrive Geoffrey O’Brien (lo ricorda il curatore della sezione su Fonda al Cinema Ritrovato 2020. Alexander Horwath): “Il Lincoln di Ford è l’immagine speculare del regista. Immagine ulteriormente rispecchiata dalla “straordinaria interpretazione di Fonda. La sua collocazione nello spazio, la sua distanza relativa da coloro che lo circondano e la sua dose di agio o disagio sono punti di riferimento costanti. Non riusciamo a togliergli gli occhi di dosso, eppure a momenti quasi scompare nella massa. La sua maturazione politica, quando affronta la folla che vuole linciare i suoi clienti, è compensata dai momenti in cui prende le distanze e guarda lontano o dentro di sé. Ogni punto di contatto e ogni perdita di contatto sono registrati con un’ipersensibilità elettrica, non da ultimo in scene che paiono immerse in una quiete pastorale”.
Come a dire che i formalismi della messa in scena e gli studi sul linguaggio classico vanno spesso a sbattere contro i nodi più particolare della significazione cinematografica e soprattutto della produzioni di effetti emotivi e nella costruzione dell’identificazione spettatoriale. Molto passa attraverso l’attore e la sua gestualità, o persino – nel caso di Ford e Fonda – attraverso una magnifica collaborazione basata su di un preciso progetto spaziale e recitativo.
Lo stesso Fonda racconta: “Non conoscevo Ford. Conoscevo i suoi film e gironzolavo sul set quando girava Ombre rosse. Me ne stavo lì davanti alla sua scrivania come un sottufficiale con il cappello bianco in mano, e lui era l’ammiraglio. Le sue parole suonarono all’incirca cosi: ‘Cos’è ‘sta stronzata che non vuoi interpretare Lincoln? Credi che sia quel cazzo di Presidente? È un giovane e inesperto avvocato di Springfield, Cristo santo’. Ed è così che mi minacciò e mi convinse”.
Un Oscar e una bottiglia
In La diva – The Star di Stuart Heisler del 1952, proiettato al Cinema Ritrovato 2020 – c’è questa meravigliosa scena di Bette Davis, attrice in declino, che afferra il suo Oscar, lo mette sul lunotto della macchina, e comincia a guidare bevendo smodatamente. Il film non è gran che e non riesce a pareggiare Viale del tramonto (e a Bette Davis deve essere dispiaciuto, persino in una sfida su personaggi di dive in crisi), però possiede alcuni assoli eccezionali. Come questo.
Ne scrive molto intelligentemente Ehsan Khoshbakht: “Girato in ventiquattro giorni, il film è ben articolato ed esplora alcuni dei temi prediletti di Heisler, come il conflitto tra maternità e carriera (Smash-Up; Tulsa) e l’esclusione da un mondo, quello dello spettacolo, che è stato al centro di sogni e sacrifici (Smash-Up). I personaggi vanno alla deriva fino al limite estremo prima di fare ritorno, feriti ma lucidi (si veda anche Journey into Light). Heisler mette a nudo le emozioni, rendendo i personaggi ancora più vulnerabili di quel che sono. A prevalere è il linguaggio del melodramma, portato qui quasi alla perfezione, ma il vagare disperato nella notte e il bussare affranto alle porte richiamano anche la logica del noir”.
Straordinario il momento in cui Bette Davis guarda se stessa nei giornalieri dopo aver testardamente chiesto di poter cambiare la propria recitazione e ringiovanito il personaggio che doveva interpretare. La donna si accorge di quanto è inappropriata e smorfiosa sullo schermo e piange se stessa. Il film, poi, è di maschilismo quasi accanito, dando alla donna un’unica via d’uscita: le braccia di un marito stabile.
“LA LETTERA ACCUSATRICE” E LA SMALL TOWN AMERICANA
Proseguiamo nell’esplorazione delle pieghe più nascoste del cinema classico, rielaborando alcuni articoli del passato (in questo caso per una vecchia collana di DVD). Oggi parliamo di La lettera accusatrice di Tay Garnett, in originale Cause for Alarm. Questo film utilizza quello che gli esperti chiamano “meccanismo di strangolamento”. Significa che il film (per lo più di genere thriller o avventuroso) comincia in una situazione apparentemente serena e peggiora via via mettendo il protagonista in un pericolo crescente. Tutto volge al peggio, fino a che – metaforicamente – spettatore e personaggio si sentono soffocare, perché ogni via d’uscita sembra preclusa. Funzionano così alcune delle migliori sceneggiature americane, e La lettera accusatrice non fa eccezione.
Girata in pochi giorni e pensata probabilmente poco più che come “b-movie”, la pellicola del 1951 si svolge quasi in tempo reale e anticipa i meccanismi di suspense utilizzati, per esempio, da un serial come 24. La protagonista, infatti, deve correre contro il tempo per fermare la missiva del marito, malato di nervi, destinata al procuratore distrettuale, nella quale la donna verrebbe ingiustamente accusata della sua morte. Su questa premessa, si snoda il racconto. La donna, impreparata a fronteggiare la crisi, commette un errore dietro l’altro e cercando di tenere celata la morte del coniuge, si comporta in maniera inconsueta con tutti coloro che la circondano e accumula omissioni e piccole bugie destinate a ritorcersi contro di lei.
Il film è girato in spazi claustrofobici: l’appartamento dove la coppia abita, il vialetto di casa, il quartiere. Al massimo ci si spinge alla fine della strada principale: è un altro accorgimento per produrre sentimenti di ansia e incertezza nello spettatore. Importante anche l’architettura interna della casa. Il pianoterra sembra appartenere all’utopia di una famiglia felice, il piano di sopra invece è il luogo della nevrosi e dell’instabilità. Quando il marito muore, la donna deve impedire a chiunque di salire le scale. La stanza della “follia” finisce fuori campo, diventa una torre inaccessibile, un confine da non oltrepassare a nessun costo.
Al di là delle evidenti caratteristiche che rendono il thriller avvincente, però, si fa strada una non banale riflessione sociale. A ben pensarci, infatti, quando la protagonista entra in crisi, l’intera, piccola comunità che la circonda diventa ostile. La vicina di casa spia e spettegola, il postino si rifiuta di restituire la lettera intestardendosi sui regolamenti cittadini, il bambino che scorrazza in bicicletta sul vialetto di casa rischia di farsi a bella posta investire, la zia del marito s’impiccia e si intromette. Il delicato quadretto che per solito siamo abituati a trovare nel cinema americano degli anni Cinquanta finisce rapidamente in pezzi. Esso diventa intollerabile per la protagonista e pericoloso per la sua innocenza. Solo il coraggio e la freddezza della donna riescono a farle affrontare una situazione che, da ordinaria qual è, si è trasformata in kafkiana.
L’aggettivo può essere usato senza remore. In fondo, il meccanismo che rischia di schiacciare la donna ha qualcosa di assurdo. Il film, del resto, deve probabilmente molta della sua energia alla lezione del noir (le cui storie criminali saccheggiavano senza ritegno Freud e Kafka) e alla nascente sfiducia nella provincia americana. Non è un caso che in quegli stessi anni – dal 1951 in poi – Philip K. Dick sviluppi i suoi angoscianti racconti brevi ambientandoli nelle piccole città statunitensi, e che l’horror investa presto le stesse, apparentemente calme, cittadine. Forse, La lettera accusatrice merita di non essere liquidato come un divertissement fine a se stesso, ma di ottenere una valutazione di più ampio respiro che ne saggi l’importanza dentro un intero contesto culturale e storico.
Che cosa ci vuole dire il film? Forse questa perfetta cittadina americana non è così raccomandabile. Forse gli abitanti apparentemente sorridenti e pacifici sanno essere molto velenosi, quando vogliono. Forse lo scandalo sociale di una moglie che può sopravvivere senza il marito è la vera posta in gioco, il vero motivo per il quale nessuno vuole aiutare la donna. O più semplicemente, La lettera accusatrice mette in guardia da chi consideriamo affidabile. In fondo, basta un po’ di malsana curiosità, di mediocre invidia per mettere in pericolo l’innocenza di una persona. Ecco perché il film, sotto le spoglie di un thriller piacevole e pieno di tensione, merita un’attenzione particolare.
Vale la pena aggiungere qualche annotazione sulla figura del marito, interpretato dall’ottimo Barry Sullivan. Il cinema americano ha avuto sempre una qualche ritrosia a rappresentare le malattie mentali, almeno fino all’epoca contemporanea dove il cosiddetto “handicap movie” ne ha mostrate numerose. Il reduce di guerra di questo film appare psicologicamente scosso e fisicamente debole. E’ un uomo chiuso in se stesso, ormai incapace di assumersi il ruolo di capofamiglia che gli spetterebbe. E’ ossessionato dall’idea che la moglie sia innamorata dell’amico medico. Passa tutto il giorno a rimuginare sul proprio sospetto e arriva persino a convincersi che i due tramino la sua morte. Qualcuno potrebbe dire che l’uomo ha visto troppi noir. Effettivamente, la sua paranoia potrebbe essere la perfetta trama di un altro film, di quel genere che abbiamo poco fa citato. E’ come se La lettera accusatrice contenesse due “mondi possibili” narrativi: quello del thriller – che il film sceglie di sviluppare – e quello del noir – che appartiene solo alla mente instabile del marito.
Il film si avvale della regia sorvegliata e rapida di Tay Garnett, regista amato dai cinefili per la sua abilità nell’adattarsi ai vari generi cinematografici e grazie alle indubbie qualità di messa in scena. Film come La taverna dei sette peccati (1940), Bataan (1941), Il postino suona sempre due volte (1946) valgono come altrettanti biglietti da visita. Sapiente nel destreggiarsi tra spazi stretti e luoghi asfittici, Garnett mostra di saper dosare la tensione e far crescere lentamente la suspense. In alcuni casi, attinge persino alla tradizione espressionista. Per due volte, ombre e silhouette si stagliano dietro la porta. Si tratta di un espediente di inquadratura e di luministica che rappresenta le angosce della protagonista. Non è cioè una visione soggettiva o un sogno a raccontarci della nevrosi incombente, bensì un effetto visivo che appartiene all’ambiente circostante. E’ una sorta di discorso libero indiretto del cinema, o – come lo chiamava Pasolini – una “soggettiva libera indiretta”: quello che vediamo è in verità filtrato e ingigantito dalla psicologia della donna.
Tuttavia, il suo film avrebbe perso di efficacia senza la protagonista, Loretta Young, parte integrante della vicenda e perfetta interprete per la parte di una donna comune alle prese con una emergenza imprevista. Attiva fin dagli anni Trenta – dopo una “gavetta” nel cinema muto -, la Young ha interpretato numerosi personaggi, riuscendo ad essere contemporaneamente materna e sensuale, spiritosa e affidabile. Ha girato commedie (La gelosia non è di moda, 1937, Mia moglie cerca marito, 1937), drammi (Le due suore, 1949), film d’avventura e in costume, finendo anche alla corte del grande Orson Welles (Lo straniero, 1946). Si tratta di un volto molto particolare, dagli occhi chiari e profondi e dalle labbra sensuali. Questa compresenza di elementi rassicuranti e particolari seducenti ne hanno fatto un’attrice versatile, forse troppo inclassificabile per diventare una diva a tutti gli effetti, ma capace di vincere un Oscar nel 1947 per La moglie celebre di H.C. Potter. Gli appassionati, comunque, la ricordano con affetto. Volle girare La lettera accusatrice come uno dei suoi ultimi film, prima di ritirarsi dal cinema e dedicarsi alla televisione e a opere di carità.
un pezzetto di POZZETTO
Mi accodo ai molti, sacrosanti ricordi dedicati a Renato Pozzetto di questi giorni, in cui il comico compie 80 anni. Si tratta di un personaggio unico nella cultura popolare italiana, fortemente legato al milieu lombardo di provenienza (come gli amici Cochi Ponzoni, Enzo Jannacci e Beppe Viola, insieme a molti altri), che ha saputo – anche grazie all’intelligenza di un produttore come Achille Manzotti – costruire un pezzetto di commedia italiana a metà tra il surreale e il pop.
Non è dei titoli più autoriale che vogliamo parlare (quelli con Lattuada o Mogherini, per esempio), e nemmeno dei due lavori con Celentano o delle commedie più addomesticate degli anni Ottanta. Piuttosto – visto che abbiamo altrove parlato di film a episodi – ci piace ricordare una sequenza (e questa è proprio la rubrica dedicata a singole scene di film), una delle più folli girate da Pozzetto. Si tratta di un breve estratto da Io tigro tu tigri egli tigra e potete rivederlo in fondo.
Il film uscì nel 1978 e fin dal titolo doveva alludere a Tre tigri contro tre tigri uscito l’anno prima con enorme successo. Siamo in una fase volgarizzata della commedia a episodi, pensata proprio per esaltare alcuni comici di grande successo, noti anche in televisione. In questa seconda fatica, Pozzetto è anche regista. Ma – quel che conta ancora di più – in scrittura troviamo Enzo Jannacci, Gianni Manganelli, Cochi Ponzoni, lo stesso Pozzetto, Italo Terzoli, Enrico Vaime, Castellano e Pipolo. Per dire. Pur stroncato dalla critica, Io tigro tu tigri egli tigra contiene alcuni momenti eccezionali come quello qui riproposto.
Oltre al momento straniante della trattoria Milan-Inter che si apre – come fossimo “ai confini della realtà – su San Siro, c’è la lunga gag della “Trattoria Semivuota”, un capolavoro di nonsense dove Pozzetto, tapino vestito un po’ da motocarrista e un po’ da pilota Ferrari, viene insultato da una vecchia locandiera, un avventore maleducato e un cuoco violento; maltrattato, servito con porzioni ridicole (e con un bicchiere di “acqua alla spina”, ovvero un bicchier d’acqua con una spina da elettricista immersa dentro), e infine cacciato in malo modo dalla stamberga.
Diretto dall’attore, questo stralcio del primo episodio (gli altri due dei tre complessivi sono con Paolo Villaggio ed Enrico Montesano diretti da Giorgio Capitani) ci dice molto della vena pozzettiana, che capitava si scatenasse proprio nei frammenti e nei lacerti che magari i processi di nobilitazione del comico rischiano di dimenticare. Nel precedente film “tigresco” i registi erano Sergio Corbucci e Steno, ma anche lì Pozzetto aveva messo il naso in sceneggiatura, e nel primo episodio – dove interpreta un prete – ci sono altre chicche tra il lunare e il demenziale, come quella dove, mentre spia Cochi con il cannocchiale da un campanile, dichiara di stare “sistemando il paesaggio”.
Dunque, per comprendere Pozzetto è abbastanza inutile separarne la figura cabarettistica più intellettuale da quella dei tormentoni musicali, la carriera di idiot savant di certo, tardo cinema d’autore dai film alimentari del periodo Lucisano (il produttore dei due titoli in questione, con la sua IIF), perché Pozzetto è una cosa sola, e il suo tocco s’imprime dappertutto, o con scene improvvise o negoziando con diversi contenitori, ragionamento del resto valido per la gran parte dei comici cinematografici.
ritorno alla “citta’ magica”
La città magica di William A. Wellman (1947) è un ottimo esempio di cinema americano che indaga sulla società ideale e sulle utopie civili. Rivedendo il film, vengono alla mente le opere di Frank Capra, che infatti avrebbe in un primo tempo dovuto dirigere la pellicola. La sceneggiatura, a sua volta, è stata scritta da Robert Riskin, abituale collaboratore di Capra. In effetti, molti dei temi cari al cineasta italo-americano compaiono puntualmente: l’ideale roosveltiano di una cittadinanza capace di cooperare per il bene comune, il pericolo di una eccessiva esposizione al mercato e ai mass media, la tentazione dell’avidità individuale, la ricerca della felicità singolare temperata dalle altrui esigenze.
Più che la città magica, quella raccontata dal film è la città perfetta. Il giornalista interpretato da James Stweart crede di aver trovato il centro cittadino più adatto a rappresentare l’intera comunità degli Stati Uniti. L’idea – statistica – è che sondando gli umori dei cittadini, si riesca a ottenere l’orientamento dell’intera nazione su materie tra di loro disparate: la politica, il gusto comune, la sensibilità sociale, insomma l’intera pubblica opinione. Come sappiamo bene, però, test, sondaggi ed exit poll vengono troppo spesso smentiti dalla realtà. Così accade anche questa volta, e i risultati delle ricerche sono troppo bizzarri per essere presi sul serio. Parafrasando il principio di Heisenberg: analizzando un processo troppo da vicino, l’osservatore finisce col modificarlo. Anche i pareri dei cittadini impazziscono, poiché essi si trovano impreparati a tutta l’attenzione che i media riservano loro, e mutano il proprio modo di sentire e vedere il mondo a seconda di chi li intervista.
La città magica dovrebbe essere proiettato nei corsi di laurea in Storia per comprendere come una certa America, democratica e ottimista, rappresentava se stessa all’altezza del 1947. La seconda guerra mondale è appena finita, e la società statunitense, grazie alla vittoria nel conflitto bellico, sembra godere di un periodo di serenità e coesione sociale. Tuttavia, qualcosa scricchiola: l’egoismo capitalista e le scalate finanziarie possono travolgere il tessuto faticosamente costruito da Roosevelt dopo la crisi economica del 1929. Ecco che film come Città magica cercano di interpretare nuovamente lo spirito che portò l’America fuori dalla crisi negli anni Trenta. E’ un grido nostalgico, quello che cerca di avvertire dei pericoli dell’eccessiva ricchezza e dei falsi doni dell’euforia generalizzata.
Il film si compone di tre movimenti. Il primo è quello dell’arrivo nella città perfetta. Essa si trova sul territorio statunitense ma è come se fosse sospesa in una sorta di surrealtà. Noi vediamo tutto con gli occhi del protagonista, accecato dal proprio preconcetto. Egli saluta ogni abitante che incontra per strada, ricevendo sguardi perplessi. Gli unici che sembrano davvero prestargli attenzione sono i ragazzi della scuola comunale, che gli chiedono consigli sul gioco della pallacanestro. La spontaneità degli abitanti convince il nostro giornalista di trovarsi nella città giusta, se non fosse per gli screzi con la giornalista del luogo, una penna acuminata che sembra aver compreso le sue intenzioni (ma l’amore è naturalmente proto a sbocciare). La seconda parte del film rappresenta invece il crollo dell’utopia. I mass media, una volta scoperta la città ideale, la sconvolgono, e la mandano in rovina, dopo averla abbandonata perché inaffidabile. E così comincia il terzo e ultimo capitolo del film, quello in cui – non sveleremo come – la città tenta di risollevare le proprie sorti, e i due innamorati di ritrovare pace e serenità.
A parte questo inquadramento ideologico, che trova certamente nel cinema di Frank Capra il suo modello principale, va detto che i meriti del film vanno anche oltre. Non c’è dubbio che il tono da commedia umanista provenga dalla lunga tradizione hollywoodiana nella cura del personaggio e del dialogo. Il protagonista è solo uno dei tanti “every day men” (uomini di tutti i giorni) che James Stewart ha saputo interpretare. Basti ricordare proprio la lunga militanza nel cinema di Frank Capra (L’eterna illusione, 1938, Mr. Smith va a Washington, 1939, La vita è meravigliosa, 1946), le collaborazioni con Ernst Lubitsch (Scrivimi fermo posta, 1940), per non parlare poi dei ruoli con Hitchcock, che secondo alcuni critici ne hanno trasformato la carriera portandolo su lidi meno ottimistici e sicuri (Nodo alla gola, 1948; La finestra sul cortile, 1954; L’uomo che sapeva troppo, 1956; La donna che visse due volte, 1958, forse il ruolo più oscuro e tragico di tutta la carriera). Dinoccolato, magro e legnoso, Stewart ha sempre evidenziato una sorta di “inadeguatezza” al mondo, di impossibilità ad essere completamente normale.
Egli è al tempo stesso il perfetto americano e il cittadino metropolitano lunare e toccato (vena folleggiante sviluppata soprattutto da Harvey, 1950). Per i motivi esposti, non ci poteva essere interprete migliore di Stewart per un film come Città magica. L’attore dà al suo giornalista senza scrupoli un’umanità impareggiabile, quella che permette all’uomo di sentirsi a casa anche senza volerlo, di trovare nella cittadina che lui stesso ha scovato il calore e la grazia della migliore provincia statunitense. Egli imparerà che quella città è “magica” perché è “everytown”, è cioè ogni cittadina d’America, con i suoi difetti e le sue bizzarrie, ma tuttavia sana e positiva come la nazione che la contiene. E’ il tipo di ottimismo e di sprone che Stewart ha saputo impersonare meglio di chiunque altro.
Il tono del film è comunque lieve. La galleria dei caratteri merita una menzione, poiché ogni personaggio rappresenta davvero un pezzo della comunità, a cominciare dai ragazzini, impegnati nel comprendere il basket e la vita, e a un certo punto persino indispensabili per la salvezza della città. Il merito di questa sensibilità narrativa è da attribuire, oltre che alla bravura del già citato soggettista, a William Wellman, cineasta oggi meno celebrato di altri, ma certamente non secondo ai nomi più noti.
Il piacere nel rivedere oggi film come La città magica sta proprio nella limpidezza del racconto e nella esemplarità della composizione. Si tratta del miglior cinema classico hollywoodiano, quello che – a fronte di una semplicità che sarebbe errato scambiare per ingenua – insegna a riflettere sulla società e sulle scelte umane.
FAR EAST FILM FESTIVAL 2020 – IL CASO Watanabe Hirobumi
Dopo la prima zingarata dentro il FEFF 2020 – ispirata a visioni anarcoidi e riflessioni estemporanee – oggi chiudiamo con la seconda e ultima incursione nella bellissima edizione online organizzata sulla piattaforma di MyMovies con i film retrospettivi. Oltre all’occasione di vedere opere a me conosciute di Im Sang-soo (The President’s Last Bang, sarcastica e raggelante ricostruzione dell’attentato al presidente/dittatore della Corea del Sud nel 1979, realizzato nel 2005 e ora già restaurato in versione non censurata) e di Hou Hsiao-hsien (Cheerful Wind, 1982, lieve, squilibrato e preziosamente indifeso), c’è stato modo di salutare il maestro Obasyashi Nobuhiko con la sua ultima mezza follia, le tre ore di Labyrinth of Cinema, girato prima di morire e summa della sua opera, un mix tra metacinema, Jodorowsky in salsa nip-pop, arte del collage e post-godardismo. Commovente nel suo assurdo e delizioso rifiuto di seriosità.
Per quanto mi riguarda, però, la vera sorpresa (e il vero bottino di conoscenza garantitomi dal FEFF) è il cinema di Watanabe Hirobumi, cineasta giapponese, capace di dirigere e prodursi i suoi film tipo ingegnoso e divertentissimo le cui presentazioni erano tutte un programma – un’inquadratura fissa tra Kaurismaki e Lynch dove ha presentato, con scenografia ironica e piena di oggetti sconnessi (tra cui ben due foto della nonna, icona-feticcio dei suoi film), ogni pellicola mantenendo un equilibrio perfetto tra aria sudaticcia e cortesia impeccabile.
I suoi film, in parte da lui stesso interpretati, stanno a metà tra cinema contemplativo contemporaneo e elementi comico-ironici non del tutto estranei a una tradizione “congelata” in stile Suleiman o Kitano. In I’m Really Good, il più tenero e meno sarcastico, le ore della giornata di alcuni bambini scorrono con immutabile monotonia salvo piccoli sprazzi di humour (l’arrivo di un venditore di libri ambulante che finisce involontariamente col diventare vittima degli stessi ragazzini che voleva truffare). In Cry il protagonista alleva maiali, mangia con la nonna e non fa null’altro per tutto il film salvo concedersi un film al cinema – dove vede proprio I’m Really Good – ma si addormenta. In Life Finds a Way, il più costruito, fa quasi una parodia del meta-film di un regista in crisi, ma i vuoti sostituiscono i pieni, mentre la salute fisica del protagonista va a farsi benedire per trascuratezza (la scena dal dentista è quasi insostenibilmente comica e sadica). In Party ‘Round the Globe, il personaggio-chiave – presente anche in altri film di questo strampalato “Watanabe Universe” – è Honda, che non spiaccica parola dall’inizio alla fine, mentre Watanabe lo incalza con monologhi senza senso e ragionamenti bizzarri.
Tutti in bianco e nero, questi film seducono perché anche quando la ricerca del personaggio “cool” o di un’ironia jarmuschiana orientale potrebbero sembrare troppo scoperte, il ricorso ai tempi morti e all’inquadratura fissa smonta con testardaggine ogni sospetto di astuzia. Il riproporsi inerme e trasparente delle azioni ripetitive di personaggi strutturano via via la nozione di tempo e la filosofia dell’autore, riuscendo a costruire per sottrazione di senso un’empatia non banale verso gli abitanti di questo Giappone insieme provinciale e mediatizzato.
Come scrive Matteo Boscarol “il discorso artistico/cinematografico portato avanti dai fratelli Watanabe (a Hirobumi come regista si affianca infatti quasi sempre nei suoi lavori anche il fratello Yuji, come autore delle musiche) [coinvolge] un po’ tutti i membri delle loro famiglie, che sembrano essere impegnati in queste produzioni dal tratto fortemente indipendente, quasi artigianale”. E ancora (citiamo perché concordiamo): “Bisogna un po’ essere dell’umore giusto per affrontarli e gustarli pienamente, abitano cioè quella zona abbastanza grigia ed indistinta che sta fra la riuscita artistica e il tentativo amatoriale. Detto questo, a lungo andare l’attenzione dello spettatore finisce per focalizzarsi inevitabilmente sull’immagine dell’inquadratura e tutto ciò che essa contiene”.
Continueremo a seguire anche in futuro questo regista e questa factory.
FROM A DISTANT OBSERVER – FAR EAST FILM FESTIVAL 2020
Dopo Biografilm e Annecy, continuiamo a esperire festival online. Le piattaforme (MyMovies in tal caso) continuano ad affinare le interfacce grafiche e a sperimentare operazioni editoriali, che – come già abbiamo detto – potrebbero in futuro non scomparire ma affiancare l’auspicabile ritorno dal vivo dei festival. Premessa: chi scrive non è un esperto di cinema orientale e, per motivi di sovrapposizioni con il lavoro, ha potuto raramente negli ultimi anni presenziare al glorioso Far East Film Festival di Udine. L’occasione è dunque benedetta, ma quanto segue ha le caratteristiche dell’osservazione “distante”, per forza di cose meno informata degli studiosi e appassionati del settore.
In ogni caso, molti film (tra quelli visti in maniera confusa e con cinefilia “ad immersione”, occhi aperti e cervello sgombro) hanno dato da pensare, a cominciare da Ashfall, il film di apertura. Un esempio perfetto di blockbuster coreano, con annessi elementi politici narrativizzati in forma epica (non senza ironia) dove sud e nord trovano un intreccio per scongiurare un disastro nucleare innescato da un terremoto devastante. Per un occidentale siamo dalle parti dei blockbuster “b” catastrofici con Dwayne Johnson, ma il respiro è decisamente più ampio.
C’è un terremoto – un certo punto – persino in Ip Man 4, episodio che conclude la bella saga con Donnie Yen. Ambientato a San Francisco a inizio anni Sessanta, con una fotografia eccezionale cui non deve essere estraneo il ricordo di C’era una volta a Hollywood, il capitolo offre finalmente una parte consistente anche a Bruce Lee, allievo del maestro, come personaggio. Ovviamente il tutto serve a sublimare la serie, che si conclude con “il meglio di”, una carrellata di momenti storici, compresa la lotta contro Mike Tyson del numero 3. La sensazione è che film come questo prefigurino e dialoghino con un pubblico ancora pop nel senso tradizionale del termine, quello che in Occidente sembra inghiottito dalle forme di consumo più algoritmiche.
Ingiudicabile, per quanto mi riguarda, l’ultimo film di Johnnie To, una sorta di melodramma sportivo giovanile intitolato Chasing Dream. Mi sembra di capire che appartiene alla filmografia più torrenziale, commerciale, di rapido consumo “Toiana”, e che To stia recentemente demansionando la sua figura autoriale. Certo è che si oscilla tra plastic kitsch quasi irritante e accensioni cromatiche, emozionali difficili da ignorare. Più potente e solido invece il ritorno di Andrew Lau, The Captain, su un capitano di aereo ancora più geniale e freddo del Sully americano. Propaganda industriale cinese pura, ma anche una rocciosissima adesione al compito.
C’è spazio negli spazi non concorsuali anche per film lontani dallo spirito primario del festival (più legato ai generi e ai racconti codificati), come I – Documentary of the Journalist, doc giapponese sulla storia di una giornalista molto scomoda e perseguitata, che scoperchia alcune nefandezze davvero preoccupanti legate all’entourage di Shinzo Abe. Nulla di nuovo sotto il sole del documentario militante, ma sicuramente coraggioso al limite dello spericolato. Di altri film (My Prince Edward, per esempio) sarebbe da dire principalmente il nitore narrativo, ma annegherebbero in valutazioni troppo ordinarie. Della bella retrospettiva dedicata al da me sconosciuto Watanabe diremo a parte.
Il cinema del nuovo millennio
Pubblicato da poco, ecco uno di quei volumi che aspettavamo. Aspettavamo nel senso che, all’altezza del 2020, un volume di guida teorica, orientamento culturale e riflessione cinematografica sui film del nuovo secolo – cioè del cosiddetto ultra-contemporaneo – era richiesto in quanto utilissimo. E più volte abbiamo anche accarezzato l’idea di scriverlo, vinti poi dalla pigrizia per un’impresa molto complessa, data la vastità della geografia cinematografica di questi due decenni.
Per fortuna c’è chi è stato più energico e attento, la curatrice Alessia Cervini, che ha dato alle stampe proprio Il cinema del nuovo millennio (Carocci, 34 euro), concependo un ricchissimo menu di interventi critici, storiografici e analitici, sia dedicati a tendenze e generi, sia concentrati su singole figure (gli studi di caso), che tradiscono forse una tendenza più cinefila, comunque di sicuro interesse.
Al solito, riportiamo la presentazione del volume, invece che parafrasarla ulteriormente: “A cosa pensiamo quando parliamo di cinema contemporaneo? A quali oggetti ci riferiamo? Il volume è una riflessione teorico-critica a più voci intorno al cinema degli anni Duemila, al modo in cui esso ha concepito le sue forme, ridisegnando i propri territori e confini e individuando nuove autorialità. Da questa indagine emerge una mappa per orientarsi nel panorama audiovisivo contemporaneo, attraverso quattro strade diverse – corrispondenti ad altrettante parti del libro: temi, geografie, autori, opere –, nel momento in cui la sua storia è consegnata a un destino i cui contorni sono ancora tutti da immaginare”.
In concreto, dopo una bella introduzione della curatrice, troviamo politica, generi, animazione, queer, documentario, serialità (Temi). Poi Europa, Medio Oriente, Maghreb, Nord America, America Latina, Far East (Geografie); alcuni autori tra cui Farhadi, Dolan, Kechiche, e alcuni film tra cui Vincere, Adieu au langage ma anche Twin Peaks – il ritorno. Mai occidente-centrico, molto attento alla produzione internazionale e alle forme in circolo nell’immaginario contemporaneo, il volume non ambisce a mettere un punto storiografico ma a costruire una esplorazione organizzata e globale dei fenomeni in atto, senza dimenticare – come si è visto – la rilocazione del cinema e le serie televisive. Il parco dei contributori (colleghi di razza) è decisamente all’altezza del compito non semplicissimo.
CRONACHE DAL BIOGRAFILM – PARTE III
Cominciato il 5 giugno 2020, il Biografilm si svolge interamente online su Mymovies, gratis. Ecco la seconda puntata delle impressioni critiche su alcuni dei film (qui le altre puntate)
I Walk di Jørgen Leth. Quando il documentarista decide di voltare la camera verso se stesso può succedere di tutto, dall’estasi alla fesseria. Leth è uno che sa il fatto suo, e che ha spesso provocato il linguaggio cinematografico in passato. Affaticato nel passo, colpito da catastrofi naturali e personali, viaggia dentro la sua vecchiaia e spiega che cosa significa perdere le forze fisiche mentre il cervello è lo stesso di prima. Tra esotismo quasi coloniale e ironia stralunata, finisce con l’erigere (letteralmente) una tomba nella foresta a se stesso. Piuttosto inclassificabile.
Because of My Body di Francesco Cannavà. Di love giver avevamo solo sentito parlare nei film di finzione. Ma di gente che aiuta a ritrovare la sessualità le persone affette da handicap ne esiste davvero. In questa cronaca di rapporto tra uno specialista e una ragazza con gravi problemi alle gambe c’è tutta la difficoltà di una pratica che chiede al tempo stesso educazione erotica e distanza col paziente. Quasi impossibile, e infatti la protagonista del doc sviluppa sentimenti forti, che sfiorano il cinema sentimentale. Il regista tiene a bada la situazione, osservando i due punti di vista e rispettando il corpo della giovane donna. Fa come il terapeuta: ne spalanca l’intimità ma ne protegge la dignità.
Sing Me a Song di Thomas Balmès. Dopo Happiness, lo stesso regista parigino torna al protagonista del primo film, dieci anni dopo, sempre seguendo le vicende del Bhutan e del buddismo tibetano. Il tema, ben chiaro, è il rapporto tra la spiritualità e la tecnologia. Se vedere gli aspiranti monaci alle prese con gli smartphone fa una certa impressione, alla lunga il confronto serrato tra il personaggio e il ruolo della modernità rischia di avere solamente l’arma dell’accostamento come mezzo narrativo ed estetico. Impaginato come un film d’autore, non si farà ricordare a lungo.
King of the Cruise di Sphie Dros. il personaggio principale del documentario sarebbe uno strano sedicente barone, che – solo, anziano e terribilmente sovrappeso – se ne va in giro per le navi da crociera per trovare un po’ di compagnia e raccontare mirabolanti storie che sarebbero piaciute al grande falsario Orson Welles. Ma in verità la protagonista è la crociera, col problema che David Foster Wallace e molti film ed episodi di serie TV recenti hanno ormai narrato il kitsch umano di queste comunità in viaggio. E diventa davvero difficile sviluppare i sentimenti di ironica pietà che la regista si sforza di suscitare.
It Takes a Family di Susanne Kovács. Il nostro film preferito del festival, insieme al vincitore (che avevamo facilmente pronosticato), Walchensee Forever. Anche qui una tormentata storia di famiglia ricostruita dalla più giovane, ma se possibile ancora più dolorosa. Per riassumere: due nonni sopravvissuti ai campi di sterminio, un padre brutalizzato dallo stesso nonno vittima dei nazisti, una madre figlia di un soldato nazista (e dunque in dissidio con i suoceri), e in generale una isterica reticenza dei parenti a confessarsi davanti alla camera. Un film a suo modo eccezionale, già pronto per essere oggetto di trauma studies storici e psicanalitici, gestito con una volontà impressionante ma senza rinunciare alla fragilità di chi capisce e perdona le ferite inferte dal male assoluto.
Abbas by Abbas Kamy Pakdel. Come ho detto anche altrove, nel doc mi piacciono i progetti chiari e dichiarati. Il regista vuole raccontare la storia di un grande fotografo di guerra (e non solo). Lo trova malato e al termine della sua vita. Nessuno ne fa una questione patetica. Il fotografo accetta di raccontarsi, e soprattutto di strutturare in dieci categorie la sua opera, in una sorta di catalogo di metacritica. Curatore di sé stesso, Abbas spiega la sua estetica e la sua pratica, si congeda gestendo l’ultimo ciak, e poco dopo la fine delle riprese muore. Tutto qui (si fa per dire, ovviamente), con grande arricchimento dello spettatore.
Gli anni che cantano di Filippo Vendemmiati. Che roba era il Canzoniere delle Lame? Gli emiliani se lo ricordano: un gruppo di cultori ed esecutori della canzone politica e resistenziale che, tra gli anni ’60 e il 1980, ha tenuto centinaia di concerti. Qui, insieme a commoventi immagini di repertorio, li ritroviamo imbiancati, sopra un pulmino, a raccontare un’epoca finita per loro stessa scelta (inutile fare la “messa rossa” viene giustamente detto da chi ha deciso di togliere la spina). Il resto viene da sé, basta avere l’affetto che Vendemmiati possiede dietro la macchina da presa.